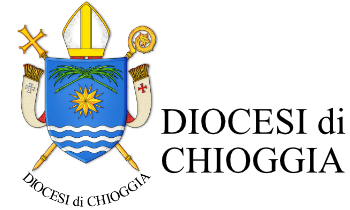1978, l’anno dei tre Papi e dei tre Padri
Questo il testo dell’intervento del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin che sabato 28 aprile nella cattedrale di Chioggia ha inaugurato il ciclo di incontri dell’associazione culturale “Il Fondaco” dedicato al tema: “Di padre in figlio. Possa Dio far ancora vivere a lungo tuo padre dentro di teˮ. Al termine della relazione il giornalista vaticanista de “la Stampa” e responsabile del sito Vatican Insider, il chioggiotto dr. Andrea Tornielli, che aveva presentato il cardinale tracciandone una essenziale biografia, gli ha posto alcune domande su temi di attualità.
I – La paternità del “timoniere del Concilioˮ
Vorrei cominciare questo mio contributo con una lunga ma significativa citazione: «Credo che di tutte le dignità di un Papa, la più invidiabile sia la paternità. Mi è capitato di accompagnare Pio XII nelle cerimonie solenni. Si gettava nella folla come nella piscina di Betsaida. Gli si stringevano contro, gli strappavano la veste. E lui era radioso. Riprendeva forza. Ma tra l’essere testimone di una paternità e l’essere personalmente padre c’è come il mare. La paternità è un sentimento che invade lo spirito e il cuore, che ci accompagna a ogni ora del giorno, che non può diminuire, ma che si accresce, perché si cresce il numero dei figli […]. Mi sento padre di tutta l’umanità […]. E questo sentimento nella coscienza del Papa è sempre nuovo, sempre fresco, allo stato nascente, sempre libero e creativo. È un sentimento che non affatica, che non stanca, che riposa da ogni stanchezza. Mai, neanche un momento, mi sono sentito stanco, quando ho alzato la mano per benedire. No, io non mi stancherò mai di benedire o di perdonare. Quando sono arrivato a Bombay, c’erano da percorrere venti chilometri per raggiungere la sede del Congresso. Folle immense, sterminate, dense, silenziose, immobili, inquadravano la strada – folle spirituali e povere, quelle folle avide, pigiate, svestite, attente che si vedono solo in India. Dovevo continuare a benedire. Un amico sacerdote, che mi era vicino, credo che alla fine mi sostenesse il braccio, come il servitore di Mosè. Eppure io non mi sento superiore, ma fratello, inferiore a tutti perché porto il peso di tutti».
Ho voluto iniziare il mio intervento con questa lunga citazione del beato – ormai quasi santo! – Paolo VI, il quale, conversando con l’amico filosofo francese Jean Guitton, gli riportava impressioni e sensazioni dopo il ritorno dal viaggio in India del dicembre 1964. Mentre pensavo a ciò che avrei potuto dirvi questa sera mi sono infatti interrogato sul perché un ciclo di incontri dedicati alla figura del padre prevedesse al suo interno uno spazio dedicato al 1978, l’anno dei tre Papi. Credo di aver individuato una possibile risposta in queste splendide parole di Paolo VI che vi ho appena proposto. L’anno dei tre Papi è stato l’anno dei tre padri. Di tre grandi padri spirituali. L’anno in cui la Chiesa cattolica nel giro di una manciata di settimane è passata attraverso la morte di Giovanni Battista Montini, l’elezione carica di speranza del suo successore Giovanni Paolo I – il veneto Albino Luciani – quindi la scomparsa repentina e inaspettata di quest’ultimo e infine l’elezione di Giovanni Paolo II, il primo Papa slavo.
Una prima considerazione, ormai a molti anni di distanza da quegli eventi storici, riguarda la santità di questi tre padri. Il beato Paolo VI sarà proclamato santo il prossimo ottobre a conclusione del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, come ha preannunciato Papa Francesco qualche settimana fa. Per il venerabile Albino Luciani si avvicina la beatificazione, alla quale lo stesso Francesco ha accennato. Mentre Giovanni Paolo II è già santo. Queste scelte compiute dalla Chiesa ci dicono che realmente abbiamo avuto in dono sulla Cattedra di Pietro figure eminenti non soltanto per umanità, preparazione, capacità di governo, profezia, sguardo capace di leggere i segni di tempi. Ma anche e soprattutto per santità personale. Quella santità vissuta che permette di tutto leggere e interpretare alla luce del soprannaturale, donando serenità e abbandono nella fede anche in mezzo alle tempeste.
Permettetemi innanzitutto di ricordare qualche dato sulla situazione in quel 1978. L’Italia aveva vissuto, nella prima parte dell’anno, il culmine dell’offensiva terrorista con il rapimento e l’uccisione dell’onorevole Aldo Moro, e il massacro dei suoi agenti di scorta. Il 22 maggio di quell’anno era stata approvata la legge sull’aborto, che tanto dolore aveva procurato in Papa Montini, già duramente provato dall’assassinio di Moro. Infine, non posso non citare, sempre a proposito del contesto internazionale, le speranze di pace di fronte agli accordi di Camp David, firmati dal presidente egiziano Anwar al-Sadat e dal Primo Ministro israeliano Menachem Begin il 17 settembre 1978, dopo dodici giorni di negoziati segreti.
La prima parte di quell’anno, come dicevo, aveva segnato indelebilmente la storia del nostro Paese. Paolo VI, il grande “timoniereˮ del Concilio che aveva condotto con mano ferma quel grande evento e aveva sofferto negli anni successivi per la crisi e la contestazione, era ormai già anziano e ammalato di una forma di artrosi che gli rendeva doloroso ogni movimento. Era stato profondamente colpito dalla vicenda Moro. Ricordiamo i suoi ripetuti appelli, compreso quello agli «uomini delle Brigate Rosse». A coloro i quali, accecati dall’ideologia, vedevano di fronte a loro non l’uomo, il padre di famiglia, il nonno, ma l’esponente di un sistema politico; a coloro i quali per odiare e per uccidere dovevano “dimenticareˮ di trovarsi di fronte a un essere umano inerme, Papa Paolo ricordava la comune appartenenza al genere umano. Chiamandoli “uominiˮ cercava di parlare ai loro cuori perché non accadesse l’irreparabile.
«Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile l’onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco, e non ho modo d’avere alcun contatto con voi. Per questo vi scrivo pubblicamente, profittando del margine di tempo, che rimane alla scadenza della minaccia di morte, che voi avete annunciata contro di lui, Uomo buono ed onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato, o accusare di scarso senso sociale e di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. Io non ho alcun mandato nei suoi confronti, né sono legato da alcun interesse privato verso di lui. Ma lo amo come membro della grande famiglia umana, come amico di studi, e a titolo del tutto particolare, come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Cristo».
Abbiamo saputo in seguito, grazie alle testimonianze dei collaboratori e di altre persone coinvolte nelle trattative, della disponibilità di Papa Montini – padre premuroso – di intervenire per motivi umanitari mettendo a disposizione anche un riscatto in denaro. Ogni tentativo fu però vano. Appena si seppe della morte di Moro, ha scritto monsignor Pasquale Macchi, «Il Papa, incredulo di fronte a tanta ferocia, chiede a me di assicurarmi sulla verità della notizia e poi, arrivata la certezza del crudele assassinio, si ritira nella sua cappella in una lunga preghiera. Posso dire che questo fu per Paolo VI un colpo micidiale che segnò la sua persona già indebolita dalla malattia e dall’età avanzata».
E abbiamo ancora davanti agli occhi, noi che in quel 1978 eravamo già adulti, il grido drammatico che Paolo VI, curvo sotto il peso degli anni e del dolore, aveva innalzato a Dio, quel Dio che non lo aveva ascoltato di fronte alla richiesta di salvare la vita dell’onorevole Moro. «E chi può ascoltare il nostro lamento, se non ancora Tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo Uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico; ma Tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spirito immortale, segnato dalla Fede nel Cristo, che è la risurrezione e la vita. Per lui, per lui. Signore, ascoltaci!».
Il 29 giugno 1978, in San Pietro, Paolo VI festeggia il quindicesimo anniversario della sua incoronazione. In cuor suo ha già da tempo maturato la certezza che quello sarà l’ultimo, e proprio per questo prepara un’omelia che rappresenta il bilancio del suo pontificato, e quasi un commiato, ricordando che «il corso naturale» della sua vita ormai «volge al tramonto». Paolo VI si volge a Pietro e Paolo, gettando – cito – «uno sguardo complessivo su quello che è stato il periodo durante il quale il Signore ci ha affidato la sua Chiesa; e, benché ci consideriamo l’ultimo e indegno successore di Pietro, ci sentiamo a questa soglia estrema confortati e sorretti dalla coscienza di aver instancabilmente ripetuto davanti alla Chiesa e al mondo: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”; anche noi, come Paolo, sentiamo di poter dire: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”».
Quell’omelia rappresenta un riepilogo del suo pontificato e vale la pena rileggerla. I due capitoli della sua riflessione riguardano la tutela della fede e la difesa della vita umana. Rispetto al primo, il Papa spiega – cito – che «la fede non è il risultato dell’umana speculazione, ma il “deposito” ricevuto dagli Apostoli, i quali lo hanno accolto da Cristo che essi hanno “visto, contemplato e ascoltato”».
«Ecco, Fratelli e Figli, l’intento instancabile, vigile, assillante che ci ha mossi in questi quindici anni di pontificato. “Fidem servavi”! possiamo dire oggi, con la umile e ferma coscienza di non aver mai tradito “il santo vero”». Quindi elenca«alcuni documenti salienti del pontificato, che hanno voluto segnare le tappe di questo nostro sofferto ministero di amore e di servizio alla fede e alla disciplina», tra i qualil’Ecclesiam Suam, laMysterium Fidei e laSacerdotalis Caelibatus «sul dono totale di sé che distingue il carisma e l’ufficio presbiterale». Sono encicliche che ci parlano di una Chiesa che si fa dialogo e incontro con l’uomo contemporaneo e che riafferma la sua fede nella presenza reale del Corpo e Sangue di Cristo nell’eucaristia, oltre che ribadire l’importanza del celibato sacerdotale per la Chiesa latina.
Papa Montini aggiunge un riferimento al “Credo del Popolo di Dioˮ – cito -: «Ma soprattutto, non vogliamo dimenticare quella nostra “Professione di fede” che, proprio dieci anni fa, il 30 giugno del 1968, noi solennemente pronunciammo in nome e a impegno di tutta la Chiesa come “Credo del Popolo di Dio”, per ricordare, per riaffermare, per ribadire i punti capitali della fede della Chiesa stessa, proclamata dai più importanti Concili Ecumenici, in un momento in cui facili sperimentalismi dottrinali sembravano scuotere la certezza di tanti sacerdoti e fedeli, e richiedevano un ritorno alle sorgenti».
Paolo VI riconosce che il peggio della crisi è ormai alle spalle (un’altra citazione): «Grazie al Signore, molti pericoli si sono attenuati; ma davanti alle difficoltà che ancor oggi la Chiesa deve affrontare sul piano sia dottrinale che disciplinare, noi ci richiamiamo ancora energicamente a quella sommaria professione di fede, che consideriamo un atto importante del nostro magistero pontificale, perché solo nella fedeltà all’insegnamento di Cristo e della Chiesa, trasmessoci dai Padri, possiamo avere quella forza di conquista e quella luce di intelligenza e d’anima che proviene dal possesso maturo e consapevole della divina verità».
Poi aggiunge: «E vogliamo altresì rivolgere un appello a quanti impegnano se stessi e trascinano gli altri, con la parola, con gli scritti, con il comportamento, sulle vie delle opinioni personali e poi su quelle dell’eresia e dello scisma, disorientando le coscienze dei singoli, e la comunità intera, […]. Li avvertiamo paternamente: si guardino dal turbare ulteriormente la Chiesa; è giunto il momento della verità, e occorre che ciascuno conosca le proprie responsabilità di fronte a decisioni che debbono salvaguardare la fede, tesoro comune che il Cristo, il quale è Petra, è Roccia, ha affidato a Pietro».
Per quanto riguarda il secondo capitolo, dedicato alla difesa della vita umana, Paolo VI parla – cito – del «dovere di favorire la promozione tecnico-materiale dei popoli in via di sviluppo», con l’enciclica Populorum Progressio. Ricorda che «la difesa della vita deve cominciare dalle sorgenti stesse della umana esistenza. È stato questo un grave e chiaro insegnamento del Concilio, il quale, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, ammoniva che “la vita, una volta concepita, dev’essere protetta con la massima cura; e l’aborto come l’infanticidio sono abominevoli delitti”, Non abbiamo fatto altro che raccogliere questa consegna, quando, dieci anni fa, promanammo l’Enciclica Humanae Vitae: ispirata all’intangibile insegnamento biblico ed evangelico, che convalida le norme della legge naturale e i dettami insopprimibili della coscienza sul rispetto della vita, la cui trasmissione è affidata alla paternità e alla maternità responsabili, quel documento è diventato oggi di nuova e più urgente attualità per i vulnera inferti da pubbliche legislazioni alla santità indissolubile del vincolo matrimoniale e alla intangibilità della vita umana fin dal seno materno». E come non ricordare, infine, l’attualissima esortazione sull’evangelizzazione, la Evangelii nuntiandi, dalla quale Papa Francesco ha più volte tratto ispirazione.
Di Papa Paolo VI vorrei anche citare un intervento di dieci anni prima, nel mezzo della crisi e delle turbolenze post-conciliari e nell’anno che segna l’inizio della grande contestazione giovanile, il 1968. Sono parole che testimoniano il suo totale abbandono alla volontà di Dio. Forse la grandezza di Giovanni Battista Montini emerge proprio in questi anni travagliati: nel suo lavorare e soffrire per mantenere unita la Chiesa, nel suo riaffermare verità di fede che qualcuno voleva mettere in discussione, nel suo non cedere alla richiesta di chi desiderava condanne definitive e provvedimenti inquisitori ai quali sarebbero probabilmente seguiti scismi. Rivolgendosi ai membri del Pontificio Seminario lombardo, ricevuti in udienza il 7 dicembre 1968, Paolo VI disse:
«Tanti si aspettano dal Papa gesti clamorosi, interventi energici e decisivi. Il Papa non ritiene di dover seguire altra linea che non sia quella della confidenza in Gesù Cristo, a cui preme la sua Chiesa più che non a qualunque altro. Sarà Lui a sedare la tempesta. Quante volte il Maestro ha ripetuto: “Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!”. Il Papa sarà il primo ad eseguire questo comando del Signore e ad abbandonarsi, senza ambascia o inopportune ansie, al gioco misterioso della invisibile ma certissima assistenza di Gesù alla sua Chiesa. Non si tratta di un’attesa sterile o inerte: bensì di attesa vigile nella preghiera».
II – Albino, il Papa dell’umiltà
Dopo la morte di Papa Montini, avvenuta nella solitudine di Castel Gandolfo, come prima di lui era accaduto soltanto a Pio XII, il Papa del quale era stato a lungo fedele servitore e collaboratore nella Segreteria di Stato, il conclave dei cardinali nel giro di poche ore elegge un successore destinato a passare come una meteora. Ma una meteora indimenticata. La figura di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, è stata troppo a lungo gravata dai gossipe dalle ipotesi scandalistiche attorno alla sua scomparsa improvvisa. Grazie a Dio, il tempo e la ricerca onesta hanno fatto emergere tutti i documenti necessari per affermare non soltanto l’evidenza di una morte naturale, ma anche di ricostruire i precedenti clinici. E dunque di poter dire una parola definitiva su quel “gialloˮ assolutamente inesistente, come si può leggere nel volume “Papa Luciani. Cronaca di una morteˮ, scritto da Stefania Falasca sulla base dell’inedita documentazione raccolta per la causa di beatificazione.
Di Luciani ricordiamo il sorriso: “Papa del sorrisoˮ fu definito. Con il rischio di far consistere soltanto in quello la profondità e la ricchezza della sua figura e del suo magistero. Credo di poter dire che Albino Luciani, prima ancora di diventare Papa, è stato un modello di sacerdote e di vescovo. Si è formato negli anni preconciliari, è stato giovane vescovo al Concilio, è stato sempre “pastore con l’odore delle pecoreˮ – per usare un’espressiva formulazione di Papa Francesco – e dunque vicino alla gente, ai drammi e alle domande delle persone.
Mi hanno sempre colpito le parole con le quali Luciani da vescovo di Vittorio Veneto, nel dicembre 1958, si presentava ai fedeli. Perché dicono tutto di lui e ci rivelano anche quale sia il grande segreto del cristiano: l’essere umile, il sentirsi bisognoso dell’aiuto del Signore. Ecco che cosa affermava: «Appena designato vescovo, ho pensato che il Signore venisse attuando anche con me un suo vecchio sistema: certe cose, scriverle non sul bronzo o sul marmo, ma addirittura sulla polvere, affinché se la scrittura resta, non scompaginata o dispersa dal vento, risulti chiaro che il merito è tutto solo di Dio. Io sono la polvere; la insigne dignità episcopale e la diocesi di Vittorio Veneto sono belle cose che Dio si è degnato di scrivere su me; se un po’ di bene verrà fuori da questa scrittura, è chiaro fin da adesso che sarà tutto merito della grazia e della misericordia del Signore». C’è qui, credo, un prezioso insegnamento anche per tutti noi.
Proprio nelle settimane precedenti alla morte di Paolo VI, nel luglio 1978, era nata la prima bambina “in provettaˮ. Ricerche e tecnologie di fronte alle quali oggi non possiamo tacere le nostre paure, perché si rischia di superare la linea di non ritorno e l’uomo manipolando la vita si attribuisce caratteristiche divine. A proposito del caso di Louise Brown, la prima “figlia in provettaˮ nata nell’ospedale di Oldham, nel Nord dell’Inghilterra, in un’intervista consegnata alla rivista “Prospettive nel mondoˮ, l’allora patriarca di Venezia Albino Luciani diceva di condividere «solo in parte l’entusiasmo di chi plaude al progresso della scienza e della tecnica». E si chiedeva che cosa sarebbe accaduto quando quella tecnica si fosse trovata davanti – cito – a «figli malformati? Lo scienziato non farà la figura dell’apprendista stregone che scatena forze poderose senza poi poterle arginare e dominare?». E inoltre, davanti al rischio di un «mercato dei figli» la famiglia e la società «non sarebbero state in gran regresso più che in progresso?». Quell’intervista non venne mai pubblicata perché nel frattempo il cardinale era diventato Papa. Sarà resa nota soltanto molti anni dopo. Luciani non mancava, in quel testo, di fare «i più cordiali auguri alla bambina», rifiutandosi di condannare le intenzioni dei suoi genitori.
Vorrei poi ricordare come la fede semplice e profonda di Albino Luciani, la sua fedeltà alla Parola di Dio e al magistero della Chiesa, lo rendessero attento ai problemi sociali. Il 23 settembre, durante la sua unica uscita dal Vaticano dopo l’elezione per la presa di possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano, che come sapete è la cattedrale del vescovo di Roma, rispondendo al saluto del sindaco di Roma, Giulio Carlo Argan, Giovanni Paolo I disse: «Alcune delle sue parole mi hanno fatto venire in mente una delle preghiere che, fanciullo, recitavo con la mamma. Suonava così: “I peccati, che gridano vendetta al cospetto di Dio sono… opprimere i poveri, defraudare la giusta mercede agli operai”: A sua volta, il parroco che mi interrogava alla scuola di catechismo: “I peccati, che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché sono dei più gravi e funesti?”. E io rispondevo col Catechismo di Pio X: “… perché direttamente contrari al bene dell’umanità e odiosissimi tanto che provocano, più degli altri, i castighi di Dio”. Roma sarà una vera comunità cristiana, se Dio vi sarà onorato non solo con l’affluenza dei fedeli alle chiese, non solo con la vita privata vissuta morigeratamente, ma anche con l’amore ai poveri. Questi – diceva il diacono romano Lorenzo – sono i veri tesori della Chiesa; vanno pertanto aiutati, da chi può, ad avere e ad essere di più senza venire umiliati e offesi con ricchezze ostentate, con denaro sperperato in cose futili e non investito – quando possibile – in imprese di comune vantaggio».
E come non citare, infine, le parole forti con le quali Papa Luciani, durante un’udienza del mercoledì in Vaticano, citò il suo immediato predecessore Paolo VI e la sua enciclica Populorum progessio: «La proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario».
L’umanità, la semplicità con la quale il nuovo Papa si era mostrato, il suo tratto affabile, la sua predicazione comprensibile a tutti, hanno conquistato milioni di credenti e anche non credenti in tutto il mondo. Le attese, le speranze, che aveva acceso quell’elezione avvenuta nell’afa dell’estate 1978 – era il 26 agosto, e un cardinale racconterà di aver violato i sigilli del conclave per far entrare un po’ d’aria dalla finestra – si spegnevano all’improvviso. La Curia romana e più in generale tutta la Chiesa aveva appena metabolizzato il trauma della morte di un Papa e dell’elezione del suo successore, quando ecco l’improvvisa notizia del ritrovamento del Pontefice senza vita nel suo letto, la mattina del 29 settembre.
III – Papa Wojtyla, l’atleta di Dio
Ed eccoci ripercorrere con la memoria quei giorni tristi e uggiosi: la lunga fila di fedeli commossi che rendono omaggio a quel Papa “magis ostensus quam datusˮ, più “mostrato che donatoˮ. A quel Papa sorridente che si era appena affacciato alla finestra del mondo nella sua nuova veste di pastore della Chiesa universale, e troppo presto la lasciava. La sorpresa che lo Spirito Santo, servendosi degli uomini, ci preparava era di quelle destinate a segnare la storia: il primo Papa slavo in duemila anni. Un Papa che veniva «di un Paese lontano» (come disse con qualche imperfezione d’italiano prendendo la parola – fatto inconsueto – al momento della prima benedizione). Un Papa di appena 58 anni, ancora nel vigore della forza fisica, abituato a fare sport, che con la sua fede ferma e incrollabile avrebbe portato una ventata di freschezza nella Chiesa giocando un ruolo importante non soltanto per dar voce a quei tanti fratelli cristiani in quel momento obbligati al silenzio nei Paesi d’Oltrecortina, ma anche nel ricordarci che l’Europa per respirare ed essere veramente sé stessa aveva bisogno di due polmoni, non di uno soltanto, quello dell’Occidente. Stiamo parlando di una storia che poco a poco si avvicina a noi.
Sarebbe impossibile qui anche soltanto ricapitolare per sommi capi il lungo e ricco pontificato di san Giovanni Paolo II, durato ben 27 anni, così denso di “prime volteˮ, di record, di continue trasferte in ogni angolo del mondo per incontrare gli ultimi, i più lontani; per annunciare il Vangelo ad ogni donna e ad ogni uomo. Papa Wojtyla ci ha donato splendide encicliche, il nuovo Codice di diritto canonico, il nuovo Catechismo della Chiesa cattolica. Permettetemi però qui di ricordarlo per il suo personale contributo di sofferenza. Forse saprete, dalla lettura delle innumerevoli biografie e dei tantissimi saggi che gli sono stati dedicati, del cruccio che affliggeva il giovane Karol Wojtyla nell’immediato dopoguerra. Lui, che aveva già sofferto molto – per la perdita della madre prima, dell’amatissimo fratello Edmund, medico, poi, e infine per la morte del padre – si era ritrovato a meditare sul perché molti dei suoi compagni e compagne di studio erano morti durante gli anni terribili del conflitto, mentre lui era rimasto in vita: «Perché loro e non io?», si chiedeva Karol Wojtyla nella nazione polacca martire prima del nazismo e poi del comunismo. Quelle sofferenze avevano preparato Wojtyla a ciò che sarebbe accaduto dopo, fino alla storica elezione del conclave che il 16 ottobre 1978 lo elesse Vescovo di Roma.
Durante il suo pontificato, la Chiesa cattolica ha attraversato un periodo di cambiamenti storici epocali. Undici anni dopo l’elezione del primo Papa proveniente dall’Est, da Oltreocortina, era caduto il Muro di Berlino. Il mondo bipolare era spaccato, il mondo dei blocchi contrapposti e della Guerra fredda, aveva cambiato completamente faccia. Il colosso comunista era imploso, era crollato rovinosamente senza spargimenti di sangue, senza rivoluzioni, senza guerre sanguinose. Karol Wojtyla aveva dato il suo personale contributo a tutto questo: un contributo di sofferenza, innanzitutto. Lui che il 13 maggio 1981, anniversario delle apparizioni della Madonna di Fatima, era stato colpito in piazza San Pietro e quasi ucciso dai colpi sparati dalla Browning calibro 38 del giovane estremista turco Ali Agca. Nella visione mistica della storia che appartiene a Wojtyla, una mano materna, quella di Maria, aveva deviato il proiettile e aveva fatto sì che il giovane e baldanzoso Pontefice eletto un anno e mezzo prima si fermasse alle soglie della morte. Rivelando il terzo segreto di Fatima, il testo redatto da suor Lucia dos Santos, l’ultima sopravvissuta dei tre pastorelli veggenti, custodito negli archivi del Sant’Ufficio per decenni, Giovanni Paolo II nell’anno 2000 si era identificato con il protagonista di quella drammatica visione profetica: era lui il «vescovo vestito di bianco» che attraversando la città semidistrutta e passando attraverso una distesa di corpi di martiri veniva lui stesso martirizzato in cima a un monte, colpito dal fuoco di fucili e da frecce.
Certo, lui, Wojtyla, non era morto. Ma non era morto grazie alle preghiere, grazie all’intervento della Madre di Dio, sotto la cui protezione lui, orfano di madre fin dalla tenera età, aveva posto tutta la sua vita di sacerdote, di vescovo e di Papa, scegliendo come suo motto una frase di Grignion de Montfort, «Totus tuus», «Tutto tuo io sono, o Maria». Quell’attentato, che il Papa vedeva inserito nel mistero di Fatima e nel lungo e spesso silenzioso rosario di martiri che aveva attraversato il Novecento. «Penso che l’attentato – aveva scritto Giovanni Paolo II nel suo ultimo libro, Memoria e identità, pubblicato poche settimane prima della morte – sia stata una delle ultime convulsioni delle ideologie della prepotenza scatenatesi nel ventesimo secolo. La sopraffazione fu praticata dal fascismo e dal nazismo, così come dal comunismo». Aveva atteso la fine della vita, l’anziano Pontefice, per dire per la prima volta così esplicitamente da dove credeva fosse venuto l’attentato alla sua vita.
Ma il Papa mistico, dopo aver chiuso l’epoca della contrapposizione dei blocchi, ne aveva vissuta un’altra, nuova, inizialmente entusiasmante. Che si sarebbe però rivelata non meno difficile e tragica. Il comunismo era caduto, ma spesso nei Paesi liberati da quel giogo opprimente e grigio non era rinata la fede, aveva invece trionfato il consumismo e intere classi sociali si erano ritrovate più povere. La fine dell’impero sovietico non aveva portato a un’era di stabilità. Ci si trovava invece, di fronte a una nuova guerra – una guerra etnica fratricida – nel cuore stesso dell’Europa. Ora il mondo era diventato unipolare e la voce di Giovanni Paolo II, così osannata quando predicava la lotta al comunismo, si alzava per chiedere di non scatenare subito un conflitto contro l’Iraq del dittatore Saddam Hussein, che nell’estate 1990 aveva invaso il Kuwait. La guerra era stata fatta lo stesso. Poi era cominciata quella nella ex Jugoslavia, terribile, lunga, accompagnata da episodi di violenza brutale che vedevano contrapposto popolo a popolo, dopo la fine del regime di Tito. Mentre in Africa, nell’Africa dimenticata da tutti, si sarebbe di lì a poco consumato uno dei genocidi più terrificanti della storia, quello del Ruanda. Tante volte la voce di Giovanni Paolo II rimarrà inascoltata.
Poi, con l’approssimarsi dell’anno 2000 e del Giubileo, il mondo sembrava avviarsi verso un’era di pace. Ma l’11 settembre 2001, con gli attentati contro gli Stati Uniti da parte dei terroristi di Bin Laden, aveva fatto ripiombare l’umanità nel baratro della paura. E il Papa al quale era stata attribuita la sconfitta del comunismo, il Papa che aveva cercato di ricostruire la legalità internazionale rafforzando il ruolo delle Nazioni Unite, si era trovato nuovamente sul fronte, a combattere contro un nemico infido, subdolo, non ben identificato: il fanatismo religioso, l’odio e la violenza terribile praticati nel nome di un credo religioso.
Karol Wojtyla aveva cercato con tutte le sue forze, ormai fragile e consumato dalla malattia, di togliere fondamento teologico a quest’assurda idea, a quell’assurda giustificazione. Aveva convocato ad Assisi nel 2002 una nuova riunione interreligiosa, aveva gridato con tutto il fiato che gli rimaneva nei polmoni che non si può e non si deve mai giustificare l’odio e la violenza usando, anzi bestemmiando, il nome di Dio. Ma questo Papa, in prima linea nel combattimento inerme contro il terrorismo, aveva saputo con grande coraggio gridare anche il suo «no» alla guerra, quando nei primi mesi del 2003 un’alleanza angloamericana aveva deciso di muovere guerra all’Iraq di Saddam Hussein. Il mondo era diventato ancora più instabile e la minaccia terroristica sembrava giustificare qualsiasi guerra, anche quella «preventiva». Oggi possiamo constatare quanto quel grido del Pontefice vecchio e malato, fosse stato profetico.
Giovanni Paolo II ha attraversato questi grandi cambiamenti epocali rimanendo sé stesso. «Il problema che ha dominato il pontificato è stato quello dell’annuncio e della difesa della fede e della morale cristiana», ha scritto «La Civiltà Cattolica», nell’editoriale pubblicato dopo la sua morte. «Infatti- continua la rivista dei gesuiti – la sua più grande preoccupazione è stata l’evangelizzazione, che egli ha voluto “nuova” nella forma e nel metodo, ma fedele alla tradizione apostolica e all’insegnamento dei concili, in particolare del Concilio Vaticano II. Con i suoi innumerevoli viaggi apostolici – che sono stati una caratteristica del suo pontificato – il Papa non solo ha inteso annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, ma ha voluto incoraggiare le Chiese locali a fare opera di evangelizzazione anche nelle difficili situazioni in cui esse talvolta vivono, per quanto riguarda la possibilità stessa di annunciare il Vangelo senza essere accusati di fare indebito proselitismo o di combattere le religioni tradizionali di ciascun paese».
«Allo scopo, poi, di dissipare dubbi e incertezze– si legge ancora nella “La Civiltà Cattolica” – sulle verità della fede e della morale cristiana ha pubblicato il Catechismo della Chiesa cattolica(11 ottobre 1992) come “norma sicura per l’insegnamento della fede”. Particolare impegno egli ha posto – in un tempo di relativismo religioso – nella difesa dell’unicità e dell’universalità di Cristo, il Verbo di Dio, incarnato, morto e risorto, per la salvezza di tutti gli uomini».
Papa Wojtyla ha traghettato la Chiesa dalla crisi post-conciliare completando l’opera di Paolo VI e l’ha spronata a un nuovo impeto missionario. Non si è risparmiato, ha mostrato la strada. Ha annunciato Gesù Cristo in ogni angolo della terra. È stato un instancabile difensore della vita umana, dei diritti umani, della libertà religiosa. Soprattutto ci ha insegnato che il cristiano non sente alcuno come nemico. Ha gettato ponti in un’epoca nella quale si alzano muri. Ha insegnato il dialogo e l’incontro con chi ha una fede diversa. È entrato, primo Papa nella storia, dopo san Pietro, in una sinagoga, a Roma nel 1986. È entrato, primo Papa nella storia, in una moschea, a Damasco nel 2001. Era un uomo di Dio, un uomo di preghiera, totalmente immerso nella storia perché totalmente immerso in Dio.
Permettermi di citare le parole che ha scritto nel messaggio per la Giornata mondiale delle Migrazioni del 1998, che conservano tutta la loro attualità: «Il fatto che qualche volta l’azione apostolica a favore dei migranti si svolga tra diffidenze e persino ostilità non può mai diventare motivo per abdicare all’impegno della solidarietà e della promozione umana. L’esigente affermazione di Gesù: “Ero forestiero e mi avete ospitatoˮ (Mt 25,35) conserva in ogni circostanza tutta la sua forza ed interpella la coscienza di quanti intendono seguirne le orme. Accogliere l’altro non è per il credente soltanto filantropia o naturale attenzione al proprio simile. È molto di più, perché in ogni essere umano egli sa di incontrare Cristo, che attende di essere amato e servito nei fratelli, specialmente nei più poveri e bisognosi».
IV – Padri perché Figli
Cari amici, ho cercato di tracciare qualche pennellata, ovviamente incompleta, su questi tre grandi padri che ci sono stati donati. Tutti e tre ci hanno educato ad amare Dio e ad amare i fratelli, perché non c’è amore sincero a Dio che non sfoci nell’amore verso i fratelli, specialmente i più piccoli e i più deboli, nel volto dei quali riconosciamo il Volto del nostro Signore. Ci hanno educato a guardare a Lui, a Dio, e a non confidare nelle nostre forze. Ci hanno educato a credere nell’efficacia del dialogo, nella costruzione di ponti e non di muri, anche quando costa sofferenza, anche quando ci sembra di seminare invano, anche quando ci sembra di andare controcorrente. Ci hanno educato a non vedere mai nell’altro un “nemicoˮ, perché il cristiano non ha nemici. O meglio, ne ha uno solo, ed è il diavolo. Gli uomini e le donne, gli altri esseri umani, sono innanzitutto fratelli, come noi immersi nelle contraddizioni e nelle difficoltà della vita di ogni giorno, come noi alla ricerca di un senso, di un significato, di una risposta. Il cristiano vive – per grazia – nella certezza della fede, ma non può mai dire di “possederlaˮ, perché così facendo rischierebbe di ridurla a ideologia. E questo sguardo, questo sentimento, questa consapevolezza di essere sempre in cammino, di aver bisogno di incontrare sempre nuovamente il Signore sulla nostra strada, ci è stato testimoniato da questi tre grandi padri. Che sono stati tali innanzitutto perché a loro volta figli. Non si può essere padre se non si è prima di tutto figlio. Il beato Paolo VI, il venerabile Giovanni Paolo I e san Giovanni Paolo II ci hanno accompagnato con la loro paternità perché a loro volta non hanno mai distolto lo sguardo da Gesù e hanno ripetuto nella quotidianità della loro vita, in mezzo a problemi, sofferenze, fatiche, paure e amarezze, quelle semplici parole dell’apostolo Pietro, del quale loro sono stati successori: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente!».
Pietro Parolin, Cardinale, Segretario di Stato
(Chioggia, 28 aprile 2018)