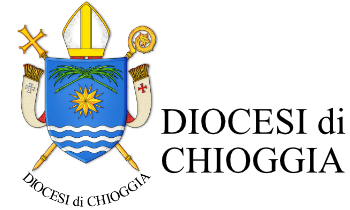SPECIALE SANTI E DEFUNTI
-I Santi e i Defunti
-La festa di “Tutti i Santi” e la vita eterna
-“I morti”, storia e tradizione a Chioggia
-In semiterio
-C’è un cimitero in fondo al mare
-Nessun uomo è un’Isola
I Santi e i Defunti
Il 1° e il 2 novembre la chiesa celebra due importanti ricorrenze
La solennità di tutti i Santi (vedi foto) cade sabato 1° Novembre, mentre domenica 2 commemoriamo tutti i Fedeli Defunti. La solennità di Tutti i Santi viene dalla Chiesa Orientale e fu accolta a Roma quando papa Bonifacio IV il 13 maggio del 609 trasformò il Pantheon in una Chiesa in onore della Vergine dei Martiri e di tutti i Santi. Il giorno 2 novembre la Chiesa, invece, fa memoria di tutti i Fedeli Defunti; tale commemorazione è dovuta principalmente all’iniziativa dell’abate di Cluny, Sant’Odilone (962-1045). Nel territorio di Chioggia il culto dei Morti è sempre stato particolarmente sentito dalla popolazione e anche ai giorni nostri elevata è la frequenza alle sante Messe nel giorno di mercoledì, per il popolo “el mèrcore de le aneme”. Nella sera e nottata del 1° novembre, vigilia della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, nessuna barca da pesca osava avventurarsi in mare, forte la credenza che si sarebbero viste galleggiare nell’acqua miriadi di fiammelle, tante quante i pescatori scomparsi tra i flutti. La sera precedente la solennità di tutti i Santi, il 31 ottobre, invece, le donne di Chioggia non lavoravano di cucito; c’era la convinzione che l’uso dell’ago – di forte simbologia scaramantica – avrebbe impedito agli “angioletti” – i bambini morti di pochi mesi, se non di pochi giorni – di partecipare alla processione dei Santi in Paradiso. Nella commemorazione dei Defunti, le famiglie benestanti regalavano ai maestri dei loro figli una zucca baruca, una zucca di Chioggia, o del caffè, un sacchetto di zucchero e un “bosson de vino novèlo”, una bottiglia di vino novello, oltre ad una “piàdena de sùgoli”, una zuppiera contenente la marmellata di succo d’uva nera, con farina, cannella e cioccolato. Ricordiamo, infine, che la chiesa del cimitero di Chioggia venne benedetta del vescovo mons. Domenico Maria Mezzadri e aperta al culto il 28 ottobre 1935. È intitolata a San Giovanni Battista e a Sant’Antonio da Padova. (G. Aldrighetti)
Nella foto: icona di Tutti i Santi.
Che la vita eterna sia desiderabile
La festa di “Tutti i Santi”
Forse nessuna festa come quella di “Tutti i Santi” o nessun ricordo come quello della Commemorazione dei defunti pongono davanti a ciascuno la domanda seria: dove andremo dopo questa vita? O, più radicalmente: c’è qualcosa dopo la morte? I credenti hanno ricevuto su questo una parola certa, cui guardare con fiducia e il Vangelo insegna che cosa aspettare con gratitudine.
L’attesa di un dopo è inscritta nel cuore di ognuno: l’uomo avverte che non può finire tutto con questa vita; sente di aspirare a qualcosa di più. Certamente, non riusciamo ad immaginare come deve essere in realtà la vita dopo la morte, ma sentiamo che c’è. Qualcosa in noi lo testimonia, lo attesta. Non è frutto della nostra immaginazione, ma piuttosto è la prova che Dio ha messo nel cuore dell’uomo la nozione dell’eternità (cfr. Qoelet 3,11). Sì Dio, dopo aver creato nel mondo bella ogni cosa, ha posto nell’uomo la chiamata a qualcosa di più. S. Agostino a questo proposito ha scritto “c’è dunque in noi, per così dire, una dotta ignoranza” (Lettera a Proba). Da soli non sappiamo che cosa ci sia dopo questa vita, ma siamo certi che qualcosa ci sia.
Questo qualcosa è quello che noi chiamiamo “vita beata” o “vera vita”. “La vera vita è quella – dice ancora S. Agostino – al cui confronto questa nostra, da noi tanto amata, per quanto piacevole e lunga, non merita d’essere chiamata vita”. E, ancora: l’unica vera vita, la sola beata è “il poter contemplare, immortali per l’eternità e incorruttibili nel corpo e nello spirito le delizie di Dio”. L’uomo è stato creato per questa beatitudine e si realizza pienamente solo così. Ecco perché i beni terreni possono essere di conforto, ma non offrono al cuore dell’uomo la pienezza che solo quelli eterni possono dare. Sbaglia l’uomo quando considera le ricchezze, le sicurezze umane, gli onori, i piaceri come la propria realizzazione. Questi possono esserci, ma si possono anche perdere; se ci sono, devono servire come mezzi per compiere il bene agli altri. Si confonde l’uomo quando considera i beni materiali come il fine della propria esistenza, come se questi offrissero la vita beata. No questa sta altrove!
Cerca l’uomo la vita vera, la vita beata? Ecco è il punto. Dio ha messo nel cuore dell’uomo il pensiero e il desiderio dell’eternità, ma questi talvolta sembrano ormai spenti. Forse a motivo di una cattiva comprensione del concetto stesso di eternità. Essa sarebbe un continuo susseguirsi di giorni del calendario, un prolungamento all’infinito delle nostre attività e relazioni. Basti pensare che il paradiso viene talvolta presentato come una continuazione materiale di questa vita, come il luogo dove le famiglie si riuniscono al sicuro per sempre. “Vita eterna” è oggi una parola insufficiente e crea confusione; “eterno” suscita l’idea dell’interminabile, del ripetitivo che annoia. Così, l’annuncio della vita eterna per molti è divenuta un’informazione, che può essere messa accanto alle tante che si possiedono su svariati argomenti.
Invece, deve tornare ad essere un annuncio, capace di orientare l’esistenza terrena, la vita quotidiana. L’eternità sarà il momento “dell’immergersi nell’oceano dell’infinito amore, nel quale il tempo – il prima e il dopo – non esiste più” (Spe salvi, 12). Questo momento, giorno che non tramonta, è la vita in senso pieno; un tuffarsi in Dio, così da essere sopraffatti dalla gioia. Sarà lo svelamento della condizione definitiva di figli, abbracciati tutti dall’amore del Padre. Se è questa, la vita eterna torna ad essere desiderabile! (Marco Doldi)
A margine della commemorazione del 2 novembre
“I morti”, storia e tradizione a Chioggia
È noto come il culto dei morti sia sempre stato e sia tuttora molto sentito a Chioggia. Basti solo constatare la notevole affluenza di fedeli alla cosiddetta “Messa del mèrcore de le àneme”, che si celebra ogni mercoledì mattina nelle varie chiese e in particolare a S. Giacomo, dove esiste un apposito altare, detto appunto “de le Àneme” (il secondo a sinistra entrando). Ma è altrettanto curioso il fatto che nel Seicento il giorno della commemorazione dei defunti (in dialetto conosciuto come “I morti”) non figuri fra la quarantina di feste di precetto in vigore nel calendario liturgico di allora (cfr. S. Perini, “Chioggia nel Seicento”, 1996, p. 420). Comunque sia, il culto dei morti ha una sua connotazione tutta particolare a Chioggia nel corso dei tempi, attribuita, come annota giustamente U. Marcato nel suo bellissimo volume “Chioggia e il suo folklore” (1978, p. 246), al fatto che “come poche altre città d’Italia, Chioggia ha conosciuto l’esperienza quotidiana della morte nel caso delle tempeste e dei naufragi, a causa di pestilenze, carestie e malattie infettive, calamità che si alternavano, in passato, ad intervalli di pochi anni”. Trascurando l’argomento “cimiteri” cittadini, già trattato in precedenti numeri di questo settimanale (vedi anche A. Padoan, “Almanacco di Chioggia”, 2006, p. 289), qui ci soffermeremo sui riti religiosi legati a questa particolare ricorrenza, tralasciando l’aspetto profano o superstizioso. Innanzitutto è da notare che nelle tre chiese parrocchiali del Settecento nella città, si celebrava quotidianamente una cinquantina di messe (circa 20.000 all’anno), messe in gran parte commissionate dai parenti dei defunti in loro suffragio. Non per nulla era sorta in epoca remota presso la chiesa di S. Giacomo la pia associazione delle “Anime del Purgatorio”, allo scopo di organizzare i riti in suffragio dei defunti, mentre “nella chiesa di S. Andrea ogni venerdì si celebrava con assidua e devota partecipazione di popolo il tradizionale rito della «buona morte» per unire al Cristo agonizzante il dolore per i cari estinti e prepararsi al trapasso estremo” (cfr. Perini, op. cit.). Il rito funebre o funerale era fino alla fine dell’Ottocento celebrato con una larga partecipazione di fedeli e in rispetto a collaudate forme tradizionali, che si differenziavano a seconda del ceto sociale e delle possibilità economiche di questo. Al funerale di un estinto appartenente ad una elevata categoria sociale partecipava di solito l’intero Capitolo dei canonici e, dopo la cerimonia liturgica in pompa solenne, la salma veniva tumulata in una chiesa o tra le mura di un monastero. Gli estinti delle classi più infime avevano un funerale presieduto invece dal solo vicario curato, assistito da qualche sacerdote, e terminava con una modesta sepoltura nel cimitero comune. Ma, sempre ricorrendo a quanto scritto dal Perini (S. Perini, “Chioggia dal Settecento all’età della Restaurazione”, 1989, p. 244), in entrambe le situazioni non appariva diverso il grado di partecipazione e il sentimento di comunione spirituale con l’estinto (che) trapelava non solo da gesti rituali come la traslazione del feretro lasciando scoperto il volto del defunto, ma anche mediante la prossimità fisica tra le sue spoglie mortali e i luoghi di vita dei parenti, (…) per cui il ricordo dei propri cari defunti attraversava con necessaria naturalezza la dimensione quotidiana della collettività e di ogni singola famiglia. I defunti, accolti nel tessuto urbano, perpetuavano così la loro presenza tra le fibre della comunità nella quale avevano compiuto il loro cammino terreno”. Nel Settecento (annota sempre lo stesso Perini) per manifestare l’atto di rinuncia ai beni terreni era consuetudine alquanto diffusa farsi vestire, prima della sepoltura, dell’abito francescano o del saio di qualche confraternita, mentre talune donne esprimevano la loro preferenza per la veste da pizzócchera, cioè di colei che apparteneva al terz’ordine francescano. “Come conforto spirituale venivano organizzati momenti di preghiera al capezzale del moribondo. Durante la veglia, le preghiere venivano intercalate da brevi pause, durante le quali agli astanti era consentito rifocillarsi” (cfr. S. Perini, “Chioggia nel Seicento”, 1996, p. 426). Elevatissima era fino alla metà dell’800 la mortalità infantile: la comprova l’altissimo numero di figli (specie a Sottomarina) – si dice fino a 15 e 18 per famiglia -, la maggior parte dei quali periva miseramente a  causa di malattie già da parecchi anni debellate. Si ricorda che “il funerale di piccole vittime di morbi infettivi era il rito abituale di ogni giorno. Non va peraltro trascurato il detto popolare abbastanza diffuso tra la popolazione chioggiotta di allora: «El Signore n’à agiutao» quando veniva a mancare qualche bocca che risultava in ‘soprannumero’ nelle famiglie numerose e povere. Ciò starebbe a dimostrare che talvolta il figlio era più temuto che desiderato” (cfr. U. Marcato, op.cit.). E, più oltre, in nota, si legge: “…questi bimbi erano detti dal volgo “fantolini”, con dolce termine etico che esprime affetto per le loro prime espressioni familiari. Pure nella immobilità della morte, essi venivano pregati di fare da intercessori in favore di quelle persone, donne soprattutto, che suggerivano all’orecchio le grazie di cui essi dovevano farsi carico presso Cristo e la Vergine in Paradiso”. Ridimensionato risulta il rituale funebre dopo che il Comune approvò il “Regolamento di polizia mortuaria” (Chioggia, 1911): i trasporti del feretro, ad esempio, vennero così disciplinati. Per la città: dalla casa del defunto al corso Vittorio Emanuele con barella portata a mano; dal Corso alla chiesa parrocchiale e da questa al cimitero con appositi carri. Per Sottomarina: con barella a mano o a spalla. Per le frazioni (S. Anna, Cavanella d’Adige, Ca’ Pasqua e Ca’ Bianca): con carretto speciale trainato a mano o da un cavallo: “Il trasporto delle salme dallo Spedale di Chioggia (situato nel palazzo Grassi, ndr) – si legge – al cimitero viene eseguito ordinariamente di notte per mezzo di barca, senza pompe funebri, a meno che la famiglia non richieda esplicitamente per iscritto il trasporto come nel caso indicato per la città” (art. 22), mentre “il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al cimitero è fatto a cura del municipio. Sarà gratuito per le salme di individui riconosciuti poveri e per le quali non sia fatta richiesta di trasporto pubblico; in questo caso dovrà essere eseguito nella forma ordinaria e più semplice” (art. 21). E infine un particolare che al giorno d’oggi farebbe rizzare i capelli a molti: la “maestosità” delle tombe. Si legge nel “regolamento”: “Non è permesso collocare monumenti, lapidi, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, incidere lapidi, né introdurre materiali nei cimiteri, senza avere ottenuta una regolare licenza scritta dal sindaco, previa domanda scritta corredata ai relativi disegni in duplo, con copia della dicitura del testo dell’epigrafe e pagamento della tassa di cui l’annessa tariffa” (art. 76). L’articolo successivo proibiva severamente la costruzione e l’applicazione di qualsiasi cinta in legname, ferro, muratura, o qualunque altro materiale attorno al tumulo: era pure proibita l’applicazione di lastre in vivo, ed in altro materiale, orizzontali, che coprissero tutta la superficie del tumulo. Angelo Padoan
causa di malattie già da parecchi anni debellate. Si ricorda che “il funerale di piccole vittime di morbi infettivi era il rito abituale di ogni giorno. Non va peraltro trascurato il detto popolare abbastanza diffuso tra la popolazione chioggiotta di allora: «El Signore n’à agiutao» quando veniva a mancare qualche bocca che risultava in ‘soprannumero’ nelle famiglie numerose e povere. Ciò starebbe a dimostrare che talvolta il figlio era più temuto che desiderato” (cfr. U. Marcato, op.cit.). E, più oltre, in nota, si legge: “…questi bimbi erano detti dal volgo “fantolini”, con dolce termine etico che esprime affetto per le loro prime espressioni familiari. Pure nella immobilità della morte, essi venivano pregati di fare da intercessori in favore di quelle persone, donne soprattutto, che suggerivano all’orecchio le grazie di cui essi dovevano farsi carico presso Cristo e la Vergine in Paradiso”. Ridimensionato risulta il rituale funebre dopo che il Comune approvò il “Regolamento di polizia mortuaria” (Chioggia, 1911): i trasporti del feretro, ad esempio, vennero così disciplinati. Per la città: dalla casa del defunto al corso Vittorio Emanuele con barella portata a mano; dal Corso alla chiesa parrocchiale e da questa al cimitero con appositi carri. Per Sottomarina: con barella a mano o a spalla. Per le frazioni (S. Anna, Cavanella d’Adige, Ca’ Pasqua e Ca’ Bianca): con carretto speciale trainato a mano o da un cavallo: “Il trasporto delle salme dallo Spedale di Chioggia (situato nel palazzo Grassi, ndr) – si legge – al cimitero viene eseguito ordinariamente di notte per mezzo di barca, senza pompe funebri, a meno che la famiglia non richieda esplicitamente per iscritto il trasporto come nel caso indicato per la città” (art. 22), mentre “il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al cimitero è fatto a cura del municipio. Sarà gratuito per le salme di individui riconosciuti poveri e per le quali non sia fatta richiesta di trasporto pubblico; in questo caso dovrà essere eseguito nella forma ordinaria e più semplice” (art. 21). E infine un particolare che al giorno d’oggi farebbe rizzare i capelli a molti: la “maestosità” delle tombe. Si legge nel “regolamento”: “Non è permesso collocare monumenti, lapidi, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, incidere lapidi, né introdurre materiali nei cimiteri, senza avere ottenuta una regolare licenza scritta dal sindaco, previa domanda scritta corredata ai relativi disegni in duplo, con copia della dicitura del testo dell’epigrafe e pagamento della tassa di cui l’annessa tariffa” (art. 76). L’articolo successivo proibiva severamente la costruzione e l’applicazione di qualsiasi cinta in legname, ferro, muratura, o qualunque altro materiale attorno al tumulo: era pure proibita l’applicazione di lastre in vivo, ed in altro materiale, orizzontali, che coprissero tutta la superficie del tumulo. Angelo Padoan
In semiterio
Vardé, mare, vardé che pressision!
Òmeni… done… poveréti… sióri…
Quanti che pianze e dixe le ‘razion!
Quanti che porte lumineti e fiori!
– Védistu, fantolin, tuta sta zente,
co’ la vien qua, no la vien qua per gnente…
Ogni croxe, ogni piera, in fra ste mure
la dixe el nome de le so crature!
Ah! che i terièri, anche in te la morte,
i xe – Dio me perdona – fortunai!
Soto i fiori e i lumini che i ghe porte,
ghe xe i so morti in paxe soterài!
E i pianze sora piere e sora croxe
e soto tera i mande pianti e voxe…
E pare che i so morti èbia anche lori
parole e pianti da lumini e fiori!
– Mama, mama, e la croxe de mio pare?
No a xe, anch’elo, in paese soterào?
– Ah! fantolin, no a xe, no qua, to pare…
perchè là zó, in Quarnero, a s’à niegào!
A s’à niegào, bambin, chi sa in che fundi!
Chissà se a sente i nostri Deprofundi!
– E alora, mama, e i fiori? E ‘l so lumin?
– Tasi, per carità! Dio che destin!
Innocente Giuseppe Lanza (1864-1931)
Nella foto: A. Romanoff, “Il funerale di un bambino della campagna nel duomo di Chioggia”, 1882, acquerello (National Art Gallery of New South Wales).
Ricordiamo i migranti
C’è un cimitero in fondo al mare
Il 2 novembre, ogni famiglia si appresta a ricordare i “suoi” morti e a onorarli con una visita al camposanto e un’invocazione più intima, più profonda. Un rito di amore per non dimenticare chi non c’è più ma non cessa di essere presente. E allora, proviamo ad “adottare” un defunto ignoto: un pensiero, una preghiera. Come il piatto in più che su tante tavole si mette per l’angelo, per l’ospite inatteso
C’è un cimitero in fondo al mare. Non vi sono lapidi, marmi o crisantemi, ma lo adornano gorgonie, posidonie e coralli. Non si sente lo scalpiccio di passi veloci nella ghiaia, né il chiacchiericcio sommesso di visitatori frettolosi, ma nella quiete del blu  profondo nuotano lenti e silenziosi pesci e polpi. Sul fondo del Mediterraneo giacciono migliaia di vite umane affondate insieme alla speranza, mentre cercavano di raggiungere se non la terra promessa, almeno un approdo sicuro. Solo a settembre, nel giro di tre drammatici giorni, per mille salvati si sono contati quasi altrettanti dispersi, un bilancio in tragico disavanzo, fatto di morti affogati di cui spesso non si saprà nulla, senza identità e senza storia. Scomparsi senza nome, senza una tomba su cui piangerli, come i soldati di due guerre mondiali che dormono nei campi di grano e papaveri.
profondo nuotano lenti e silenziosi pesci e polpi. Sul fondo del Mediterraneo giacciono migliaia di vite umane affondate insieme alla speranza, mentre cercavano di raggiungere se non la terra promessa, almeno un approdo sicuro. Solo a settembre, nel giro di tre drammatici giorni, per mille salvati si sono contati quasi altrettanti dispersi, un bilancio in tragico disavanzo, fatto di morti affogati di cui spesso non si saprà nulla, senza identità e senza storia. Scomparsi senza nome, senza una tomba su cui piangerli, come i soldati di due guerre mondiali che dormono nei campi di grano e papaveri.
Oggi non c’è chi canta i migranti che riposano sul fondo del mare, vittime di una guerra non combattuta, fuggiti dai conflitti e dalla carestia per soccombere per mano dei mercanti di uomini. Il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa è affondata un’imbarcazione proveniente dalla Libia: 366 morti, 20 dispersi, 155 superstiti. Un anno dopo, le immagini girate dal fotoreporter Francesco Zizola, ci restituiscono la straziante e muta testimonianza di ciò che è accaduto, di quel che rimane, con la nave adagiata a 50 metri di profondità sul fondale sabbioso, giocattolo abbandonato spezzato da un gigante fanciullo. Il relitto giace sul fondo, piccolo Titanic senza la prima e la seconda classe, senza le sale da ballo e le porcellane, senza il salone delle feste e l’orchestra. Piuttosto traghetto di Caronte, la si immagina stipata di uomini, donne e bambini impauriti, affamati, disperati. Di loro restano pochi resti, dispersi. Nell’azzurro uniforme una ripresa inquadra un incongruo luccichio rosso: una tenda damascata appesa a un oblò, che resiste e ondeggia con la marea non col vento. Nel silenzio si sente solo il respiro regolare e profondo del sub, si intuisce il rumore delle bolle che salgono verso la luce, si immagina il fremito veloce delle pinne dei pesci che passano e corrono via. Il peschereccio è inclinato di lato, le reti ad ancorarlo sul fondo, ricoperto di alghe e incrostazioni di molluschi che vi hanno trovato e fatto casa. Inesorabile e indifferente, la natura ha preso il sopravvento e ha reso il relitto parte del paesaggio, come se nulla fosse accaduto.
Come da noi in superficie. Le incrostazioni del quotidiano e l’avanzare di altre emergenze hanno steso la patina del dimenticato su quanto accaduto. In fondo, si dice, gli sbarchi continuano, chissà quanti affondano e non lo sappiamo, e poi sono già tanti qui che non sappiamo più cosa farcene. Che importa di chi è morto? Non lo conoscevamo. “Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro – ha detto Papa Francesco proprio a Lampedusa –. La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti ‘innominati’, responsabili senza nome e senza volto”. L’indifferenza è un killer silenzioso, che cresce nella mancanza di empatia e sfocia nell’individualismo egoista, consumando la coscienza di ciascuno. L’antidoto risiede anche nella capacità di sentirsi parte della stessa umanità, che si costruisce con gesti concreti di aiuto, ma prende l’avvio dal riconoscersi fratelli, anche nel dolore. Il 2 novembre, ogni famiglia si appresta a ricordare i “suoi” morti e a onorarli con una visita al camposanto e un’invocazione più intima, più profonda. Un rito di amore per non dimenticare chi non c’è più ma non cessa di essere presente. E allora, proviamo ad “adottare” un defunto ignoto: un pensiero, una preghiera. Come il piatto in più che su tante tavole si mette per l’angelo, per l’ospite inatteso, perché anche nel cimitero più silenzioso c’è sempre una campana che rintocca. (Emanuela Vinai)
Nessun uomo è un’Isola
Nessun uomo è un’Isola,
intero in se stesso.
Ogni uomo è un pezzo del Continente,
una parte della Terra.
Se una Zolla viene portata via dall’onda del Mare,
la Terra ne è diminuita,
come se un Promontorio fosse stato al suo posto,
o una Magione amica o la tua stessa Casa.
Ogni morte d’uomo mi diminuisce,
perché io partecipo all’Umanità.
E così non mandare mai a chiedere per chi suona la Campana:
Essa suona per te. (John Donne)
da NUOVA SCINTILLA 41 del 2 novembre 2014