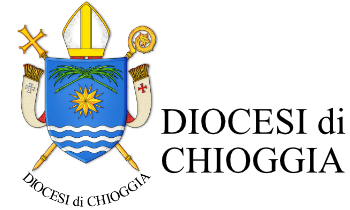Un ultimo caro saluto al salesiano don Giorgio Marchiori
Mercoledì 11 dicembre 2013, in punta di piedi così come ha vissuto questi ultimi anni della sua vita, il salesiano don Giorgio Marchiori, che fu per dieci anni a Chioggia, ci ha detto: “Arrivederci, amici, ci lasciamo per incontrarci in un altro luogo, nella casa del Padre”.
Don Giorgio: un uomo, non solo un prete salesiano; figlio di operaio, come amava ricordare. A 28 anni, nel 1967, arriva a Chioggia, “novello sacerdote” e vi rimane fino al 1976. Noi scout diciottenni avevamo il sangue che ribolliva e di ritorno dalle processioni cantavamo a squarciagola “…. il vaticano brucerem, con tutti i preti. …”, ma ai nostri preti, o meglio ai nostri assistenti volevamo bene. Di don Giorgio avevamo colto subito il buon umore, la sua grande capacità di sdrammatizzare le situazioni, la reale apertura al mondo dei giovani. Si vedeva che faticava ad accettare le nostre provocazioni (lui, d’altra
parte, era un prete ed era stato educato in un seminario), ma si impegnava e non metteva dei NO alle nostre domande, non si nascondeva dietro frasi fatte, comode per lui. Accettava il confronto senza addolcirlo e chiedeva corresponsabilità: per farla maturare ci sosteneva, ci lasciava spazio, ci aiutava a crescere. Con lui il gruppo scout, pur tra le mille difficoltà di quegli anni, ha visto il passaggio del “bastone del comando” dall’assistente ecclesiastico al “consiglio di gruppo” (l’insieme dei capi responsabili dei branchi, reparti, clan). Una vera esperienza di democrazia, di assunzione di responsabilità, un passaggio fondamentale verso la maturità di un gruppo che, con don Giorgio, ha imparato a spaziare oltre l’ombra del proprio campanile per proiettarsi verso l’esterno, la provincia, la regione.
E poi con il tempo “don Giorgio” divenne semplicemente “Giorgio”, nell’esperienza comune tra uomini e donne, di diverse età, che si rispettano, si vogliono bene, si chiamano per nome. Proprio per questo, Beniamina ed io, abbiamo voluto che fosse lui a celebrare il nostro matrimonio. Con lui abbiamo vissuto anche il difficile periodo del referendum sul divorzio e la fatica di mettere insieme le diverse idee dei capi. Trovato un punto di incontro, decidemmo di organizzare un serata con persone del mondo cattolico che esprimevano opinioni diverse e invitammo l’avvocato Bighin, ma due giorni prima l’incontro fu bloccato: don Giorgio e un altro dei vecchi capi decisero di non effettuarlo temendo gli strali di chi non avrebbe gradito e accettato che in un ambiente legato alla Chiesa ci si potesse liberamente confrontare su quel tema. Eravamo in un periodo di “muro contro muro”! Don Giorgio, qualche tempo dopo, si scusò con me (che ero uno dei capi schierati sulla “libertà di scelta”) per questo suo intervento di censura e, dopo il referendum, mi accolse come amico nonostante fossi stato allontanato dalla parrocchia in cui svolgevo il servizio di capo. Per questo gli sono rimasto sempre amico, perché lui non accettava quel muro di isolamento che era stato costruito attorno a noi che avevamo scelto, nella nostra libertà, di sostenere le ragioni del referendum. Per lui ero una persona che a suo avviso aveva “sbagliato”, ma restavo sempre un amico a cui stare vicino e di cui essere il confessore. Per questo, quando nacque la nostra prima bambina, chiedemmo che fosse lui a battezzarla. Restammo amici nel tempo: pochi incontri per la verità, ma ogni volta era un confronto arricchente, senza tabù, un confronto aperto e sereno sul nostro “essere Chiesa e appartenere alla Chiesa”; a volte il confronto era anche ruvido: lui aveva comunque scelto l’obbedienza pur mantenendo la sua libertà di pensiero, io avevo fatto una scelto di rottura, convinto che non sempre l’obbedienza è una virtù. Più di trent’anni dopo, quando andai a trovarlo per la prima volta a Mestre, in casa Zatti (la casa di riposo dei salesiani con problemi di salute) mi sanguinò il cuore: era a capo chino, lo sguardo perso, triste. Mi avvicinai senza farmi vedere e con le mani gli coprii gli occhiali e gli dissi: “Buon giorno, reverendo, mi fa un sorriso?”. Si scosse tutto, alzò la testa, il suo viso sorrideva non solo con la bocca. “Giorgio, che fai qui, con tutte le cose che hai da fare?” mi disse. “Sono qui perché ti voglio bene” gli risposi. Ad ogni uscita del giornalino del Mappamondo andavo a trovarlo e gli lasciavo una copia, che lui si faceva leggere dalle suore. Parlavamo di tutto: di politica, molto di Chiesa, della mia famiglia e della sua condizione; a fatica esprimeva il suo pensiero, trovava con difficoltà le parole giuste per esprimere quello che aveva nella testa e questo lo faceva soffrire molto. Sentiva il suo corpo come una gabbia e chiedeva perdono a Dio perché non riusciva ad accettare serenamente la sua condizione; i suoi occhi lacrimavano quando pensava ai ragazzi che aveva lasciato in Romania. Esprimeva sempre un pensiero “libero”, il pensiero di un uomo che pur avendo scelto l’obbedienza manteneva libero il cuore e la mente ed era capace di incontrare tutte le persone, di riconoscere i propri limiti. Era un piacere parlare con lui e, superato il dolore che provavo nel vederlo in uno stato di profonda sofferenza, l’incontro era sempre proficuo per tutti e due. Così accadeva ogni volta che andavo a trovarlo, e ogni volta la sua sofferenza diventava più grande, la sua capacità di trasmettere il pensiero era sempre più difficile. Ma il sorriso c’era sempre e appena sentiva la voce la testa si alzava, il suo cuore si rallegrava e sorrideva. Quando gli dissi che Beniamina ci aveva lasciato ed era tornata alla casa del Padre, restò zitto per molto tempo: gli occhi lacrimarono a lungo. Era un uomo, non soltanto un prete: un uomo che sapeva amare, soffrire, coinvolgersi nella vita del popolo, sbagliare e chiedere perdono, perdonare senza giudicare, accogliere, mettersi nelle mani di Dio.
Arrivederci, don Giorgio! Arrivederci, Giorgio, amico mio! (Giorgio Rossi)
da NUOVA SCINTILLA 48 del 22 dicembre 2013