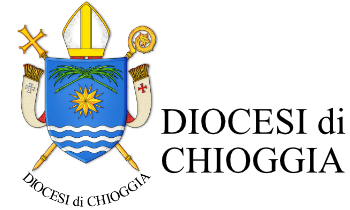Ampia partecipazione al Corso di aggiornamento per i sacerdoti della diocesi a Torreglia. Le relazioni
Liturgia come “azione” di tutti
Il corso di aggiornamento residenziale per i sacerdoti della diocesi si è svolto da domenica 13 ottobre sera a martedì pomeriggio. Nella casa di spiritualità “Sacro Cuore” di Torreglia ci siamo trovati, una sessantina di preti, per mettere a tema “La liturgia: arte e luoghi della presidenza”. Dopo cena, domenica sera, la prima relazione è stata guidata con filmati e slide da don Gaetano Comiati: molto interessante la sua presentazione per comprendere sempre più i luoghi della celebrazione. Centro della chiesa è l’altare e l’ambone: Parola ed Eucaristia celebrata sono il riferimento per tutti i partecipanti all’azione liturgica. Il Signore risorto convoca i suoi amici e per loro si fa Parola e Pane di Vita. Il tabernacolo non perde la sua
importanza, ma sarebbe più indicato per la preghiera personale e per la custodia dell’eucaristia\viatico. Naturalmente non tutto ciò che piace è sempre realizzabile ma coglierne il significato profondo e preciso è ricchezza per tutti, consacrati e laici.
Lunedì mattina, dopo la messa concelebrata, con don Pierangelo Ruaro, sempre di Vicenza, ci siamo soffermati sulla realtà teandrica dell’azione liturgica: noi spesso la riduciamo a mera azione dell’uomo, ma essa è principalmente azione di Dio e dell’uomo. La liturgia è relazione, viva ed efficace, con Dio salvatore che salva la sua creatura, la salva con i segni e simboli che fanno perenne memoria della Pasqua del suo Figlio. Quindi la liturgia non è solo parola\parole ma anzi è proprio il contrario: è agire, dove pure la parola è un’azione (chi proclama e chi ascolta compiono delle azioni). Ogni “attore” – presidente, ministri, assemblea, coro, salmista, animatore liturgico – è chiamato a trasmettere un’esperienza concreta, con saggezza ed equilibrio, per evitare personalismi o deviazioni. La liturgia eucaristica, ma non solo, deve farci esperire il dono di amore. Passaggio obbligatorio diventa la riscoperta dei linguaggi non verbali: tutto l’uomo prega, con tutti i sensi: il gusto, l’odorato, il tatto, la vista e l’udito. Celebrare è vivere quanto suggerisce il salmo “gustate e vedete come è buono il Signore!”.
Liturgia non è solo parola ma è un’azione articolata da una pluralità di linguaggi e attori. Dovrebbe essere davvero finito il tempo in cui si dice “vado ad ascoltare messa”: partecipo all’assemblea dei fedeli! Verrà il tempo, già profetizzato, in cui spetta al sacerdote la sua propria parte e non la somma di quanto spetterebbe a molti altri preoccuparsi?
Una seconda riflessione ci è stata offerta sulla omelia. Il Concilio Vaticano II l’ha resa obbligatoria nelle domeniche e feste, ma consigliata pure nei giorni feriali. Essa non ha uno scopo moralistico né deve ammantarsi di retorica aulica. Dovrebbe invece inserirsi “ad arte” nel contesto rituale e condurre l’assemblea ad entrare nel mistero che è a tema in quella celebrazione: è un entrare nell’Oggi che Dio ci consegna! Potrebbero essere sufficienti pochi minuti, evitando di metterci dentro tutto il possibile (letture, giornate locali o nazionali, feste, santi, morti, vita sociale, politica, filosofia), ma centralizzando il tema e offrendo con puntualità il banchetto della Parola. Per altre cose ci possono essere la preghiera dei fedeli o gli avvisi. Omelia significa discorso familiare, colloquio intimo: e questo dovrebbe essere lo strumento per far incontrare il volto di Gesù Maestro e Signore. Anche sulla musica e la presenza dei cori sono state offerte opporune indicazioni. Essi sono strumenti perché emerga la voce orante di tutta l’assemblea: solo una vera e sincera attenzione a questi elementi farà della liturgia terrena un’unione alle voci degli angeli e dei santi che girono e notte cantano alla santità e grandezza di Dio. Il coro non deve mai coprire l’assemblea né tantomeno ammutolirla; come pure non è vero che tutta la musica e le canzoni religiose sono liturgiche. Ecco perché servono conoscenza e preparazione, senza affidarsi alla improvvisazione, né lasciando prevalere un gusto personale: non celebriamo noi stessi e la nostra bravura, ma Lui e le sue opere!
Il vescovo ci ha spronato a fare seria attenzione a queste relazioni (che arriveranno ai sacerdoti pure via mail) ed ha raccomandato che non ricada tutto in un individualistico: “Faccio quello che voglio”.
L’ufficio liturgico diocesano si attiverà per offrire ulteriori piste di riflessioni e indicazioni pratiche. (don Nicola Nalin)
da NUOVA SCINTILLA 39 del 20 ottobre 2013
Le tre relazioni di don Pierangelo Ruaro
Prima relazione
L’ARTE DI PRESIEDERE
Il gesto di riunirsi dell’assemblea alla domenica per la celebrazione eucaristica è l’azione più comune delle nostre parrocchie, ma è anche una delle pratiche più complesse e impegnative.
Soprattutto è maturata la convinzione che il prete con la sua presidenza è uno dei soggetti decisivi per la qualità della celebrazione; da chi presiede dipendono in gran parte la buona riuscita e la bellezza di una liturgia, ma anche la nostra partecipazione, attiva e interessata o passiva e annoiata.
Si può cogliere meglio questa centralità del presidente se appena mettiamo a confronto il celebrante di ieri con quello di oggi. Non è difficile ricordare come celebrava il prete di una volta, e si parla di poco più di sessant’anni fa. Molti di voi hanno fatto esperienza diretta. Ai più giovani qualche flash per farsi un’idea.
L’osservazione più immediata è che allora il prete diceva messa con le spalle rivolte ai fedeli e che questo era decisivo. Il sacerdote, in genere, non si preoccupava affatto di rapportarsi al popolo, né si domandava in presenza di quale tipo di assemblea si trovasse; neppure lo impensieriva come la gente potesse partecipare alla celebrazione. La sua attenzione era fissata sul rito, sulla sua esecuzione corretta, sulla fedeltà alle indicazioni del messale.
Di conseguenza l’aspetto soggettivo passava in secondo ordine perché le rubriche prevedevano tutto: dal modo di vestirsi, ai gesti più minuziosi da fare, al modo di dire e proclamare le preghiere e i testi liturgici. La sua corporeità, la sua persona doveva solo obbedire e adeguarsi a quanto prescritto, assumendo un atteggiamento composto e raccolto, solenne e ieratico.
In pochi anni le cose sono radicalmente cambiate: è bastato al prete il semplice gesto di ‘girarsi’ e di porsi ‘di fronte’ al popolo, in posizione frontale davanti all’assemblea, perché di colpo il suo ‘pre-siedere’ avesse a che fare con l’assemblea e con la sua soggettività.
Ora il presidente non ha solo il compito di eseguire bene le preghiere previste dal messale, ma anche quello di far entrare un’assemblea nella preghiera della Chiesa.
Se prima la sua espressione personale scompariva dietro l’oggettività e la neutralità delle rubriche liturgiche, oggi, posta sotto lo sguardo diretto dell’assemblea, tutta la sua umanità si rivela. Se un tempo contava in primo luogo la sua funzione sacerdotale, il suo essere uomo del sacro, oggi colui che presiede viene guardato e giudicato non solo come prete, ma anche come persona che ha qualità e limiti.
Ancora: oggi il prete ha l’importante compito di valorizzare le celebrazioni tenendo presente i tempi particolari dell’anno liturgico e di prestare attenzione alle differenti componenti della comunità.
Per esempio, la presenza dei ragazzi alle liturgie richiede cure e soluzioni pastorali e liturgiche del tutto particolari; così, è diverso presiedere una liturgia abituale di ogni domenica da quella dei tempi forti; la celebrazione di una messa ‘normale’ e le liturgie dei battesimi, dei matrimoni, dei funerali e di particolari festività.
Si può intuire, insomma, che questo movimento rituale del ‘voltarsi’ e di porsi ‘di fronte’ all’assemblea può essere considerato come segno semplice ma insieme forte di un passaggio decisivo tra un prima e un dopo che ha coinvolto la Chiesa ma anche la società.
Si è trattato di un passaggio messo in atto da una diversa concezione della liturgia e della Chiesa, da un altro modo di vedere il prete e insieme il celebrante.
In questo movimento, c’è dentro tutto il Concilio e la sua riforma e si può dire che la fatica e la lentezza della sua ricezione hanno camminato insieme alla fatica e alla incertezza dei preti ad assumere, forse ancora oggi, questa nuova figura di presidenza.
Alcuni preti, soprattutto a ridosso del Concilio, si sono irrigiditi di fronte al rinnovamento. Altri hanno pensato di uscire da un eccesso di rubricismo, che ‘ingessava’ la loro gestualità ed espressione personale, solo con un protagonismo che appariva loro tanto più spontaneo e vero quanto più era slegato da ogni regola ed esigenza rituale. Spesso, infine, la lodevole intenzione di introdurre l’assemblea alla liturgia rinnovata, si è trasformata in spiegazione e in didascalia tanto invadenti da ridurre la liturgia quasi a catechesi e a discorso morale.
Infine il vento della modernità, con tutte le sue esigenze di soggettività e di personalizzazione, è andato a riflettersi nei modi concreti di celebrare e di fare presidenza, dove ciascuno mette in opera non solo dei riferimenti rituali ‘oggettivi’, ma fa ‘funzionare’ aspetti legati alla propria personalità, spiritualità e cultura pastorale.
Ecco alcuni esempi: ci può essere il prete tutto preso dalle dimensioni sentimentali e affettive della fede che, allora, sente la liturgia come momento forte di raccoglimento. Il rischio è quello di un fervore intimistico e di un eccesso di sentimentalismo.
Se viene data, al contrario, importanza alla dimensione ‘profetica’, di funzione critica della fede, di denuncia e di testimonianza, il presidente sarà prevalentemente sbilanciato ‘all’esterno’, si calerà nei problemi del nostro tempo. Il rischio è quello di strumentalizzare il rito come occasione di una predicazione che penderà troppo sul versante della critica morale e sociale.
Alcuni celebranti hanno soprattutto il senso del dovere e delle regole. La liturgia è un ‘ufficio’ da compiere fedelmente in conformità a ciò che prescrive la Chiesa. Il rischio è quello del formalismo, di un tono inespressivo nel celebrare.
Ancora, una versione di celebrazione, oggi molto richiesta è quella che punta tutta su un clima caldo e fraterno. La fede viene vista e presentata soprattutto come fraternità, condivisione, convivialità. Nella liturgia ciò che conta è sentirsi bene insieme, è l’essere uniti; i valori più apprezzati del rito saranno la partecipazione dell’assemblea, il ruolo attivo di un maggior numero di persone, il calore e il senso di vicinanza che si sente all’interno dell’assemblea. Il rischio è che l’assemblea si rinchiuda su se stessa, e il presidente cada in un eccesso di familiarità e si riduca più che a rappresentare un Altro e a suscitare la conversione, ad essere parte e specchio del gruppo.
Il ruolo specifico del presidente
Non si presiede per sé. La stessa parola «Presiedere» indica una relazione, un rapporto. Si dice «presiedere un’assemblea», e in questo caso si evidenzia il rapporto di chi presiede con un insieme di persone, con quei cristiani che sono riuniti nella circostanza per un’azione liturgica.
Oppure si dice «presiedere una celebrazione», e in questo caso si evidenzia il ruolo specifico di chi presiede in rapporto a quell’azione rituale.
Colui che presiede interviene nell’azione liturgica a doppio titolo.
– Per un verso, come credente, fa parte dell’assemblea celebrante, vi è dentro, ed è chiamato a partecipare alla celebrazione in modo «cosciente e attivo» insieme a tutti gli altri e come tutti gli altri.
– Per altro verso, colui che presiede – in ragione precisamente di questa sua funzione – sta di fronte all’assemblea, si distingue da essa ed è chiamato a esercitare una specifica responsabilità nei confronti sia dell’assemblea, sia del rito.
Come presiedere?
San Paolo esorta chiaramente: « Chi presiede lo faccia con diligenza » (Rm 12,8), cioè con vivo senso di responsabilità e coscienza della delicatezza e importanza del ruolo. Chi presiede «sta davanti» con la persona, il volto, i gesti, che rivelano l’intensità della fede e la capacità di far comunione e di coinvolgere nella partecipazione.
L’OGMR, al n. 93, richiede « dignità » nel presiedere; tale esigenza si potrebbe tradurla con: decoro della persona e del portamento, gestualità appropriata, flessibilità della voce in modo da non essere monotona ma nemmeno artefatta o enfatica, sguardo espressivo, capacità di adattamento, senso del ritmo, gusto del bello. Tutto dovrebbe dare origine a uno stile celebrativo, che rivela il presidente e la sua comunità e conferisce un tocco particolare alla celebrazione.
Oggi uno dei problemi sta nella necessità di superare lo schema riduttivo di una liturgia solo parlata.
Circa lo stile, i professori italiani di liturgia, scendendo al particolare scrivono: « Molte volte ciò che fa la differenza tra una celebrazione e un’altra è il senso delle sfumature. E quello che si suol chiamare lo stile. Un presidente che si agita sull’altare, che osserva tutto (e lo lascia vedere), che richiama e rimprovera, che va da una parte all’altra del presbiterio per compiere funzioni che non gli competono (accendere e spegnere luci, spostare microfoni, inserire dischi, portare calice e patena all’altare, ecc.) non è un buon presidente » (CSV 138).
Circa lo stile, che oggi viene chiamata arte di celebrare, riprenderemo alcune riflessioni nel pomeriggio.
Sentieri che aiutano a vivere significativamente la presidenza.
Lasciarsi «prendere» dalla celebrazione
Si tratta di un’«arte» assai impegnativa che va oltre i limiti di una pura «tecnica»; essa giunge a coinvolgere e compromettere al livello più profondo la persona di chi è chiamato ad esercitare il ministero della presidenza.
Ogni celebrazione liturgica, infatti, è un atto di preghiera ecclesiale. Ma l’atto del «pregare» non consiste nel far «eseguire» materialmente formule e riti, per quanto esteriormente corretti; si realizza come tale («pregare») solo nella misura in cui il soggetto orante si pone consapevolmente alla presenza di Dio e impegna se stesso davanti a Dio nei gesti che compie e nelle parole che proferisce, identificandosi personalmente e con verità in quelle parole e in quei gesti.
Per formarci alla presidenza liturgica è essenziale la piena e profonda autenticità umana in ogni atto e forma di preghiera, rifiutando costantemente ogni cedimento alla tentazione del formalismo rituale. In caso contrario, colui che presiede si comporta semplicemente come un funzionario (del culto).
Farsi carico della preghiera di tutti
In secondo luogo, la liturgia è preghiera ecclesiale. Ciò comporta, in chi ha l’incarico di presiedervi, una duplice responsabilità.
La prima responsabilità riguarda i presenti, i quali costituiscono — insieme con lui — quella concreta espressione della «Chiesa-qui-ora» che è ogni legittima assemblea liturgica.
Nella liturgia, infatti, colui che presiede è chiamato a farsi guida, interprete e animatore della preghiera di tutta l’assemblea. Il che significa che, per esercitare bene il ruolo di presidenza liturgica, non bastano la fede, il raccoglimento e la pietà personali; occorre sapersi immedesimare nell’assemblea presente, così com’è (numero, età, tipo di cultura, linguaggio, condizioni, situazioni… dei presenti).
In questa prospettiva, la formazione all’arte di presiedere parte da lontano, dall’educazione al senso degli altri, dall’educazione all’attenzione, al rispetto, alla capacità di ascolto, di comprensione e di adattamento nei confronti degli altri.
Presiedere è servire
L’identità propria del presbitero va pensata essenzialmente in termini di «servizio alla Chiesa, popolo di Dio». Questo vale in particolare per la presidenza delle azioni liturgiche.
Uno degli aspetti di questo servizio starà nell’impegno e nella capacità di reperire, formare e coordinare nella loro azione altre persone disponibili a svolgere con adeguata competenza i vari «uffici e ministeri» necessari o utili per il buon svolgimento delle celebrazioni. Ma è difficile formare altri allo spirito di servizio (che non è esibizione…) se non lo si vive in prima persona.
A livello personale, poi, bisognerà ricordare che tutto ciò che si fa in quanto presidenti di una celebrazione, dev’essere compiuto in funzione dell’assemblea e di quella assemblea. Presiedere in spirito di servizio significa accettare in partenza di essere condizionati (e a volte abbastanza pesantemente…) dall’assemblea che di fatto si presiede. Per cui ogni celebrazione andrà impostata e preparata — nel suo insieme come nei suoi particolari — non in base ai gusti personali di chi presiede, bensì tenendo conto di volta in volta delle persone concretamente presenti, e in funzione della loro migliore partecipazione possibile.
Mediare tra norma e creatività, tra universale e particolare
La natura ecclesiale della liturgia comporta poi per chi presiede una seconda responsabilità: quella di manifestare concretamente il rapporto di unità e di comunione che lega ogni singola assemblea o comunità cristiana con tutta la Chiesa.
La liturgia non «appartiene» in proprio a nessun prete e a nessuna comunità determinata. Il senso e il valore di un rito liturgico va sempre «al di là» dell’azione visibile di questa o di quella assemblea particolare, in quanto per natura loro le azioni liturgiche appartengono «alla Chiesa» come tale (cf. SC 26), che è sempre «più grande» delle singole comunità e assemblee.
Per imparare a presiedere bene la liturgia è quindi necessario coltivare un autentico spirito ecclesiale in due direzioni: la comunione/servizio nei confronti della comunità locale; la comunione/fedeltà nei confronti della Chiesa universale.
In concreto significa, da una parte, celebrare e presiedere nel pieno rispetto della disciplina e delle norme liturgiche vigenti; dall’altra, saper valorizzare al meglio quelle possibilità di creatività e di adattamento alle singole assemblee, che sono previste e proposte dalle norme stesse che regolano l’attuale prassi liturgica.
Nella nota pastorale CEI II rinnovamento liturgico in Italia, si dice che la riforma domanda ai ministri del culto di saper essere mediatori tra il libro e l’assemblea, tra le norme universalmente valide e le esigenze proprie della singola comunità.
«Senza distogliere gli occhi dalla tua gente» (Is 58,7)
Questo compito di mediazione è tutt’altro che facile. Per un verso, infatti, si tratta di purificare ed elevare, la qualità della fede e della preghiera dell’assemblea. Per altro verso, si tratta di rendere accessibile al massimo quanto si celebra alle persone che compongono l’assemblea celebrante.
Per fare da «mediatori» tra il libro e l’assemblea, bisogna conoscere bene l’uno e l’altra. Conoscere un’assemblea vuol dire conoscere la gente che concretamente la compone. Non solo anagraficamente, ma piuttosto culturalmente: significa non vivere «fuori del mondo», seguire con attenzione i fenomeni sociali e culturali che, in un modo o nell’altro, toccano la vita di tutti, sforzarci di parlare il linguaggio del nostro tempo e della nostra gente, e così via.
Da questo punto di vista anche il giornale e la televisione fanno parte della formazione all’arte di presiedere.
«Dare anima» a gesti e parole
Infine, nella formazione alla presidenza liturgica, bisogna mettere in conto l’acquisizione di una buona capacità di espressione e di comunicazione. Anzitutto per quanto riguarda il linguaggio della parola; ma anche per quanto riguarda il linguaggio del corpo, degli atteggiamenti, dei gesti e delle cose.
Sarebbe utile, per coloro che sono chiamati al servizio della presidenza, che, oltre a curare la propria padronanza della lingua italiana, potessero frequentare qualche corso di dizione ed educazione della voce… La ‘parola pubblica’ richiede un certo tono di voce, una scansione chiara, un ritmo adeguato.
E’ molto importante anche la padronanza dei codici non-verbali della comunicazione, a cominciare dal proprio modo di atteggiarsi, di muoversi, di gestire, di stare in piedi o seduti, di fare un segno di croce o una genuflessione, ecc..
La liturgia, infatti, è insieme parola e gesto. Anzi: più «gesto» che «parola», perché nella liturgia anche il «dire» si inscrive nel registro del «fare». Ora, per un verso il gesto è il linguaggio allo stato nascente; per altro verso, tutti i gesti che si fanno nella liturgia hanno una «portata» (un senso) che va oltre la loro materialità fisico-tecnica e il loro significato storico-culturale: in ultima analisi rimandano sempre al mistero di Cristo, con tutte le sue implicazioni trinitario, ecclesiologiche ed escatologiche.
Concludo ricordando che la presidenza non riguarda solo il momento liturgico. La presidenza si esercita già prima.
Anzitutto si presiede (cioè si serve, si interviene) nella vita della comunità, nell’impegno pastorale. Il prete non è semplicemente «ministro del culto ». Lo specifico dei ministri ordinati consiste nel fatto che essi, mediante la predicazione e la cura pastorale, generano la Chiesa e sono abilitati a esprimere coerentemente nella liturgia quello che effettivamente vivono. E’ « vero » presidente chi è buon pastore. Il vertice di una presidenza si ha nel momento liturgico; ma la sua giustificazione si fonda nel servizio pastorale. Solo chi, come Cristo e in dipendenza da lui, è capo e guida della comunità e per essa consuma continuamente la vita, può compiere il gesto rituale di agire in persona Christi.
Seconda relazione
L’ARTE DI CELEBRARE
Leggevo qualche tempo fa un articolo dove si diceva che il prete, chiamato ad essere uomo di comunione e responsabile della comunità, deve necessariamente essere dotato di una buona capacità relazionale. La relazionalità è una delle qualità essenziali all’esercizio del ministero ordinato, e si traduce nella promozione e nella attuazione di forme concrete di fraternità, corresponsabilità e collaborazione.
Secondo i vescovi italiani, tra i più rilevanti atteggiamenti virtuosi del ministro ordinato c’è proprio «la capacità di relazionarsi in modo maturo con altre persone o gruppi di persone» (Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, n.2).
Questa qualità è richiesta al prete affinché la sua personalità sia, come afferma Pastores dabo vobis (n.43), «ponte e non ostacolo per gli altri nell’incontro con Gesù Cristo Redentore dell’Uomo».
Va tenuto presente che uno dei tratti tipici dell’uomo post-moderno è proprio il desiderio di relazione, che può essere interpretato come un bisogno intenso, implicito e diffuso di inter-soggettività autentica. Basta pensare l’effetto dirompente che ha avuto in questi mesi l’immediatezza comunicativa di papa Francesco su molti cristiani e anche su molti non credenti: una comunicazione un po’ meno esposta sul piano concettuale a favore di una gestualità, nuova per un papa, percepita come espressiva e sincera.
Se questo vale per tutta la vita e per i diversi settori in cui il prete dovrà rendersi presente, in modo particolare l’aspetto relazionale va curato e pensato relativamente al momento della presidenza liturgica.
Infatti, il gesto del riunirsi dell’assemblea alla domenica per la celebrazione eucaristica è l’azione più comune delle nostre parrocchie, ma è anche una delle pratiche più complesse e impegnative. Di conseguenza anche il compito di chi deve condurre, stimolare, orientare l’assemblea all’incontro con Cristo entra a pieno diritto tra i compiti più delicati richiesti dal ministero presbiterale.
Oggi è maturata la convinzione che il prete con la sua presidenza è uno dei soggetti decisivi per la qualità della celebrazione; da chi presiede dipendono in gran parte la buona riuscita e la bellezza di una liturgia, ma anche la partecipazione, attiva e interessata o passiva e annoiata dei cristiani.
Chi presiede una celebrazione può essere ponte od ostacolo nell’incontro con Gesù Cristo, a seconda della capacità di comunicare, di entrare in collegamento con le persone; e la gestualità appartiene esattamente a questa esperienza, perché il gesto liturgico ha il compito di farci uscire da noi stessi per creare il collegamento con gli altri, e soprattutto per condurci e condurre a Dio, nell’istante del suo agire per noi.
Dove si radica questa cura per la gestualità, per il modo di stare e di rapportarsi con l’assemblea, da parte di chi presiede?
Molte volte la fede ci è stata presentata come una questione di ‘sapere’, di conoscere per aderire a un insieme di verità dogmatiche e di valori morali e sociali. Se, però, giocando con la parola, spostiamo indietro l’accento, dal verbo italiano ‘sapere’ passiamo al termine latino ‘sàpere’, che significa “aver sapore, gustare”.
Proprio la liturgia, con il suo modo di comunicare, ci conduce verso un modo «saporoso» di vivere la fede, perché la radica in una esperienza sensibile.
Ciò che le nostre orecchie sentono, ciò che i nostri occhi vedono, ciò che le nostre mani toccano, ciò che il nostro odorato respira e ciò che il nostro palato gusta, questo è il luogo primario in cui prende forma il nostro comune e personale incontro con Dio nella liturgia. Lo ricorda S. Giovanni nella sua prima lettera (1Gv 1,1-3).
Nel famoso inno allo Spirito, Veni Creator, troviamo un versetto che dice: “Accende lumen sensibus”. Quanto questa preghiera invoca, come dono dello Spirito, lo possiamo affermare anche della liturgia: essa accende di luce i sensi. Ed è questo il motivo per cui, secondo Romani Guardini, il grande compito della Chiesa è quello di imparare l’atto di culto: il culto come atto.
Papa Francesco ci sta insegnando che non bastano le parole, o i concetti. Conta molto anche la sonorità con cui queste parole vengono dette. Perché i concetti influiscono sulla mente, ma la sonorità esercita un influsso su tutto il corpo dell’uditore, è rivolta e tocca i cinque sensi. Contano i gesti e gli sguardi. Perché le parole stesse hanno un corpo. La verità che esse esprimono non coincide semplicemente con il concetto che contengono. Per capire bene il concetto, dobbiamo ascoltare il suono della voce e guardare l’espressione del viso di chi ci parla. Quello che rende manifesto il senso autentico e vero delle parole è normalmente nascosto nella luce degli occhi, nei timbri della voce, nella mimica del volto, nei movimenti del corpo. Le parole dicono perché il corpo parla.
Negli Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”, la liturgia è definita come «luogo educativo e rivelativo» in cui la fede prende forma e viene trasmessa. (n. 39).
Nella liturgia la fede “prende forma”. Per questo è necessario tornare a prendere sul serio la ‘forma’ in cui si celebra; e oggi questo aspetto è sottovalutato o addirittura spaventa. Perché c’è sempre la paura di ricadere nei vecchi ‘formalismi’. Ma prendere sul serio la forma è altra cosa dal tornare al formalismo. Si tratta di prendere coscienza che il caratteristico della liturgia consiste nel comunicare la fede in modo “sensibile”, cioè attraverso i sensi. I riti parlano perché vivono dello spessore della corporeità e usano il linguaggio dei sensi dell’essere umano. Essi comunicano non attraverso la spiegazione di idee ma attraverso gesti, cose, simboli. Se la liturgia dà forma alla fede, al “senso” cristiano della vita, lo fa attraverso i sensi.
Nelle nostre celebrazioni soffriamo ancora di una certa mancanza di stile. Si oscilla ancora troppo spesso tra i due estremi di una nostalgica solennità cerimoniale, spesso rigida e solo formale e una più superficiale disinvoltura, il più delle volte, banale e scadente.
E’ necessario riprendere con coraggio l’esortazione conciliare alla formazione liturgica. Una formazione che, oltre alla storia, alla teologia e alla pastorale della liturgia, aggiunga anche una quarta traiettoria di studio: l’educazione al ‘come’ si celebra, con attenzione alla dimensione antropologica della ritualità.
L’arte di celebrare
Quando parliamo di arte, noi siamo talmente abituati a pensare solo ai capolavori contenuti nei musei o della storia della musica, che corriamo il rischio di dimenticare che l’arte riguarda in modo uguale anche le arti applicate, come le arti della cucina o della sartoria, per non parlare dell’arte di vivere, l’arte di arrangiarsi.
Quando vogliamo provare a far le cose bene, tutti noi compiamo azioni con arte, anche senza rendersene conto: modo di vestirsi, di condurre una conversazione, di sistemare la casa, di ricevere gli amici, di imbandire la tavola per un pasto di festa… Sono tutte “arti del fare”.
Ebbene, la celebrazione liturgica si situa interamente in quest’ambito dell’arte del fare.
arte…
La parola ‘arte’ proviene dalla radice indo-europea R’tam, che significa ‘mettere in ordine’, come le parole ‘ aritmetica, ritmo’, e un’altra che ci interessa ancor di più qui: la parola ‘rito’.
Che si tratti di colori o di suoni, di legno o di cemento, di fiori o di piatti…l’arte sarà sempre una mettere in ordine diversi elementi che formeranno un tutto unitario combinandosi ad altri.
… di celebrare
L’arte di celebrare non si riduce alla presenza di oggetti d’arte nella celebrazione. Si può fare una celebrazione in una chiesa gotica con un calice del XVII° secolo, eseguendo una messa di Mozart, indossando tutti i pizzi più preziosi, lavati nel tè … e celebrare male. L’arte di celebrare consiste nel celebrare con arte.
‘I riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità ed evitino inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente di molte spiegazioni’ (SC 34).
In altre parole si può fare una celebrazione in una chiesa modesta di campagna, con un calice semplice e canti ordinari, e celebrare con arte, perché i diversi elementi della liturgia sono ordinati in modo dignitoso e armonico.
E’ questo che intende il numero 34 della SC quando dice che i riti devono manifestare ‘nobile semplicità’. L’arte di celebrare dunque consiste nel mettere in buon ordine gli elementi visibili, udibili, toccabili, gustabili, odorabili che costituiscono la celebrazione e permettono all’invisibile della fede e della grazia di essere manifestato.
Si tratta di mettere in buon ordine gli spostamenti, gli atteggiamenti e le posture, le parole e i gesti, le letture e i canti; e ancora: intervenire nei tempi e negli spazi adeguati, mantenere il tono giusto della comunicazione, in una buona coerenza con ciò che precede e ciò che segue, in una buona corrispondenza tra ciò che viene fatto e ciò che viene detto.
Si celebra con tutto il corpo
La liturgia è eminentemente corporale: si nutre di gesti (segno della croce), di atteggiamenti/posture (in ginocchio, in piedi), di movimenti (processioni) e anche di azioni compiute sul corpo (unzione con l’olio, aspersione con l’acqua). Purtroppo veniamo da una tradizione che ci ha abituati a considerare il corpo con una certa diffidenza, soprattutto per quanto riguarda l’espressione della spiritualità. Basta pensare alla difficoltà, ancora oggi, di molte persone, di ricevere la comunione sulla mano, o di alzare le braccia per pregare il Padre nostro…
La tentazione di contrapporre l’anima al corpo è antica quanto la presenza dell’uomo sulla terra. Già Tertulliano (+ 220) dovette intervenire sull’argomento per difendere la sacramentalità del corpo quale strumento indispensabile per incontrare la salvezza. è nota la sua frase «Caro salutis cardo»: la nostra carne, il nostro corpo con tutte le sue facoltà sensitive, è il cardine, lo strumento fondamentale della salvezza.
La riforma liturgica del Vaticano II ha riconosciuto e restituito al corpo e a tutte le sue facoltà, la piena dignità di strumenti ‘liturgici’ per esprimere il dialogo con Dio nel pieno rispetto della dinamica dell’incarnazione: «l’uomo è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell’ultimo giorno» (GS 14).
Il corpo partecipa alla celebrazione in diversi modi: assumendo alcune posizioni, compiendo gesti, col digiuno, con le lacrime, rivestendosi in un certo modo… A volte la celebrazione esige un concorso di vari elementi o atteggiamenti corporali per esprimersi più chiaramente, più intensamente, con maggiore autenticità.
La liturgia, dicevamo sopra, accende di luce i sensi. Ce lo ricorda la parabola (Lc 15,11-32) dell’amore misericordioso del Padre per il figlio ritrovato, incontro che è paradigmatico di ciò che avviene ad ogni liturgia: è un incontro che si fa abbraccio per il tatto, musica e suoni di festa per l’udito, vitello ingrassato per il gusto, vestito nuovo e profumato per la vista e l’olfatto.
Pensiamo alle posizioni del corpo. Il modo di stare più importante, il più nobile, il più liturgico, se così si può dire, è lo stare in piedi. Posizione dell’uomo nella sua dignità: piedi a terra, con il capo levato verso il cielo. E’ la posizione normale della preghiera comune nella quale tutto l’essere è rivolto verso Dio.
Alle letture ci si siede (eccetto che per il Vangelo, per rispetto alla Parola di Cristo): atteggiamento di ascolto, in cui l’essere si raccoglie, si interiorizza perché l’attenzione sia massima.
Si è ugualmente abituati a mettersi in ginocchio; a dire il vero è una posizione che la liturgia non privilegia; la considera come un atteggiamento penitenziale, e alcuni. concili antichi l’hanno proibita la domenica, giorno della Risurrezione (Concilio di Nicea, nel 325: “poiché vi sono alcuni che di domenica e nei giorni della Pentecoste, si inginocchiano, per una completa uniformità è sembrato bene a questo santo concilio che la preghiera a Dio si faccia in piedi”). Quella in ginocchio, di per sé è una posizione che si addice di più alla preghiera personale.
In talune grandi circostanze, la liturgia prevede anche la prostrazione: alle ordinazioni, o all’inizio della funzione del Venerdì Santo. Atteggiamento estremo, il massimo aderire alla terra; non lascia indifferenti né chi lo compie, né chi ne è testimone.
Va presa in esame anche la posizione delle mani. Darsi la mano è un segno di confidenza; si dice che il gesto proviene dall’epoca in cui attestava che ci si avvicinava all’altro senza armi nelle mani.
Al momento della comunione si è invitati a tendere la mano. Chi ha l’occasione di distribuire la comunione ogni giorno ne vede tante: c’è gente che si avvicina con le mani in tasca… possiamo dire (se lo spirito corrisponde a quello che il corpo esprime) che dal modo in cui si presenta la mano, si vede la qualità del rapporto con Dio.
La processione di comunione assomiglia spesso a una coda davanti alle casse di un supermercato. Ci sono persone che allungano la mano ma poi con le dita si prendono il pane consacrato. E’ il segnale che non si è capito il simbolismo di questa azione.
La processione di comunione dovrebbe esprimere il nostro desiderio di Dio, che si esprimerà concretamente nella mano tesa per ricevere il corpo di Cristo. Per ricevere la comunione noi ci mettiamo in cammino, entriamo in una processione, perché siamo pellegrini verso il Signore, per passare con lui da questo mondo al Padre; ognuno si muove e tutti ci muoviamo, perché il cammino è personale e insieme comunitario. Attendiamo in fila, come mendicanti e come mendicanti tendiamo la mano, per significare la nostra situazione di povertà davanti a Dio. Infine non ci prendiamo da soli il pane eucaristico ma lo riceviamo sulla mano, perché si tratta di un dono del Signore, e fino a prova contraria un dono non ce lo prendiamo da soli, ma lo riceviamo. Non sono io che con i miei sforzi conquisto il Signore ma è il Signore che, nella sua infinità bontà, si dona a me.
L’OMELIA
«Il motivo per cui la Chiesa ha posto il Credo dopo l’omelia è per invitarci a credere nonostante ciò che abbiamo ascoltato». Questa affermazione provocatoria, pronunciata qualche anno fa dal card. Tomas Spidlik, oltre a denunciare la scarsa qualità o significatività e aderenza alla vita di molte (troppe) omelie, esprime bene anche la delicatezza dell’atto liturgico affidato al predicatore.
Nella sua forma più semplice, l’omelia è la traduzione e la spiegazione della parola di Dio. L’esempio più tipico, sotto questo aspetto, è l’omelia di Esdra, sacerdote e scriba, ai deportati che erano tornati dall’esilio di Babilonia (Ne 8,1.8). Nella sua forma più alta, è l’attualizzazione della parola di Dio per la comunità che sta celebrando. L’esempio più tipico è, qui, l’intervento di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Dopo la lettura del libro di Isaia, Gesù comincia la sua omelia con queste parole: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito» (Lc 4,2 1).
Il greco homilia significa conversazione, colloquio familiare. L’omelia partecipa al mistero stesso di Gesù: egli appariva come un uomo familiare, ma nello stesso tempo era Figlio di Dio. Così l’omelia appare come una conversazione familiare, ma è nel contempo parola di Dio. Certo, essa non ha il valore universale che possiede la Bibbia in cui la chiesa riconosce l’autentica parola di Dio, ma essa è parola di Dio per la comunità celebrante.
Il cuore dell’omelia è, dunque, l’attualizzazione della Parola proclamata. Non si tratta solo di comprendere il senso letterale dei testi biblici, di coglierne il messaggio e poi di ri-esprimerlo usando il linguaggio corrente. L’omelia deve fare anche questo, ma l’attualizzazione è qualcosa di più profondo e ricco: si tratta di farci sentire protagonisti della storia santa raccontata dalle letture, di avvertirla come nostra, una storia che ci riguarda. Di conseguenza avvertiamo quelle parole, scritte in un tempo lontano, come parole che parlano di noi e a noi. Per questo a Natale, duemila anni dopo l’evento, il cristiano può ripetere: «Oggi è nato per noi il Salvatore!». Proprio per celebrare l’«oggi» dell’azione di salvezza di Dio, ogni volta che la parola è proclamata deve essere attualizzata. Perciò è bene tenere l’omelia ad ogni messa e ad ogni celebrazione della Parola. Non occorre che sia lunga. Possono bastare anche due o tre minuti. E’ essenzialmente con l’omelia che la Bibbia si fa Parola.
Le esequie cristiane
Per chiudere, solo un accenno, con riferimento all’ultimo libro liturgico che ci è stato messo a disposizione, cioè al rito delle esequie.
I fatti dimostrano che, se sono sempre meno le persone che partecipano alle celebrazioni cristiane, questo ‘dissanguamento’ delle chiese non sembra toccare le celebrazioni funebri. Numerose famiglie, (ben più di quante frequentano la comunità eucaristica domenicale), si rivolgono alla Chiesa per domandare la celebrazione delle esequie o un rito di commemorazione (settimo, trigesimo, anniversario). Nessun’altra celebrazione liturgica tocca tante persone, più o meno credenti, più o meno praticanti, quanto la celebrazione delle Esequie. Di conseguenza, si impone una attenzione particolare da parte di chi esercita il compito della presidenza.
Il fatto che tanta gente partecipi ancora ai funerali, è legato certamente ad una solidarietà che emerge più facile e naturale di fronte all’evento morte, ma anche al fatto che la morte interroga e inquieta tutti. Anche in un tempo di secolarizzazione avanzata, la perdita di una persona cara è un’esperienza drammatica ma anche ricca di tracce di trascendenza. La morte ha in sé qualcosa di sacro. Credenti o non credenti, di fronte alla morte si percepisce qualcosa che ci supera: sappiamo che il nostro congiunto è morto, eppure continuiamo ad avvertire, misteriosamente, la sua presenza. C’è un qualcosa che sembra andare oltre la morte: si continua ad amare la persona defunta, si continua a sentirsi amati da lei. Per qualcuno questo si trasforma in atto di fede, per qualche altro rimane solo una sensazione emotiva: l’evento delle esequie costituisce, dunque, un’opportunità speciale per una possibile riscoperta della fede, un terreno particolarmente adatto per l’annuncio del vangelo.
Per questo si «richiede una particolare attenzione nella scelta dei testi più adatti, nell’omelia e nelle monizioni, nei canti da eseguire e nella cura dei gesti da parte dei ministri» (Presentazione RE 6).
Che cosa si propone di celebrare la Chiesa attraverso i riti e le preghiere che danno forma alle esequie cristiane? Sicuramente la consolazione, il conforto e la preghiera per i parenti che piangono la scomparsa di un loro congiunto. Ma soprattutto la fede in una vita senza fine con il Cristo risorto: la morte come pasqua, cioè come passaggio.
In tutte le culture, i riti funebri sono riconosciuti come riti di passaggio da una situazione personale e sociale (mondo dei vivi) a un’altra (mondo dei morti).
Questo passaggio può essere visto in due modi: o verso una fine, la chiusura di un tempo, di una relazione con gli altri e con il mondo, oppure verso un nuovo inizio di tempo, di relazione, di vita.
Le esequie laiche appartengono al primo modo: il loro obiettivo è far permanere il ricordo del defunto nelle persone che hanno avuto relazione con lui, perché il defunto, non avendo più un’esistenza individuale autonoma, ha finito di esistere. Le esequie cristiane hanno lo stesso punto di partenza ma approdano non alla fine del defunto, ma a una sua nuova vita e a una nuova relazione «con i suoi».
Al centro delle esequie non c’è tanto il ricordo del defunto, quanto l’annuncio della vittoria di Cristo sulla morte che ‘oggi’ si compie a favore del credente defunto; la proclamazione che il defunto è passato con Cristo dalla morte alla vita, dalla sconfitta alla vittoria: la Pasqua di Cristo, infatti, ha stabilito una relazione indistruttibile; per questo Paolo può dire “sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore”(Rm 14,8). La relazione con il Signore (iniziata con il Battesimo) dura oltre la morte!
La celebrazione delle esequie è la celebrazione di un esodo pasquale: perché anche noi in qualche modo dobbiamo uscire da un Egitto ed entrare in una Terra Promessa. Il defunto sperimenta la sua uscita dall’Egitto di questa vita terrena e il suo ingresso nella Terra Promessa del cielo, la Gerusalemme celeste dove è accolto dagli angeli e dai santi.
Noi, Chiesa terrena, sappiamo di poter compiere con il defunto soltanto un tratto del viaggio, per cui, a conclusione della celebrazione in chiesa, chiediamo alla Chiesa del cielo di venire incontro al defunto per condurlo fino al paradiso: “In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano alla santa Gerusalemme”.
Sappiamo che, nella concreta gestione delle esequie, tutta una serie di richieste (dalla possibilità di interventi spontanei, di segni particolari da porre o di musiche da ascoltare od eseguire perché amate dal defunto), sta creando non poche difficoltà, sia a livello di equilibrio celebrativo, sia soprattutto riguarda al senso di ciò che si celebra. Non si tratta di fare una colpa ai fedeli che chiedono di intervenire dato che la loro è una richiesta mossa da una sincera solidarietà e desiderio di partecipazione. Si tratta piuttosto di renderci conto che al centro della celebrazione non stanno le nostre emozioni, ma che, pur con tutto il bagaglio emotivo che l’evento porta con sè, noi proclamiamo la nostra fede e affidiamo a Dio (questo è il significato religioso della parola “addio”) l’intera esistenza di un fratello e ringraziamo Dio perché in questo fratello, in ciò che ha vissuto e condiviso con noi, è Dio stesso che si è fatto vicino.
Terza relazione
LA LITURGIA EDUCA ATTRAVERSO IL CANTO
Ci occupiamo in questo incontro di un linguaggio che ha una funzione fondamentale nell’ars celebrandi: il canto. Lo facciamo, però, in un modo diverso rispetto a siamo abituati a pensare. Non il canto come repertorio, antico o moderno, monodico o polifonico; non il grande capitolo dei tesori della musica sacra da conservare, oppure la ricerca di un linguaggio rispondente alla sensibilità odierna. Normalmente è attorno a questi tempi che si sviluppano le grandi discussioni sul canto liturgico.
A noi, in realtà, interessa che il culto cristiano, fin dalle sue origini, ha sentito la necessità di utilizzare il particolarissimo linguaggio del canto per vivere l’assemblea liturgica e celebrare l’incontro con Dio. Dobbiamo ricordare, infatti, che il canto liturgico, in origine non è legato all’attività corale. La prova è che la presenza dei cori nella liturgia, prima del IV-V secolo, non è documentata, mentre fin dall’inizio è presente il canto. Il canto, e il motivo del canto in liturgia, viene prima della nascita dei cori.
I cristiani: la gente del canto
Perché la Chiesa tiene in così grande considerazione il canto? La risposta più semplice è che da sempre i cristiani si sono distinti per il fatto di cantare.
Basta pensare che la testimonianza storica più antica in cui si parla dei cristiani, risale al tempo di Plinio il Giovane, che ha scritto all’imperatore Traiano per chiedergli come doveva comportarsi con i cristiani. Egli ha presentato i cristiani in questo modo: sono coloro che ‘si riuniscono in un giorno fissato per cantare un inno a Cristo chiamandolo come Dio”.
Per lui i cristiani erano gente che canta a Cristo, la gente del canto. E’ una delle più belle definizioni dei cristiani, fatta proprio da uno che li vedeva dal di fuori ma che aveva intuito che cosa li caratterizzava maggiormente.
Questo, però, non significa attribuire ai cristiani il merito di avere inventato il canto. Prima di tutto perché il canto è elemento essenziale già nella religione ebraica (basta pensare ai salmi). Ma soprattutto perché cantare è un atto profondamente umano. La ragione prima del cantare dei cristiani non è religiosa, nemmeno estetica ma antropologica. E’ importante cantare per i cristiani perché è importante cantare per l’uomo.
Il canto è un segno rivelativo di una particolare situazione in cui si trova una persona. Si canta per comunicare. E l’uomo ha la necessità di comunicare: ‘non è bene che l’uomo sia solo’ (Gen. 2,18a).
Prima di essere un linguaggio organizzato, il canto e la musica sono espressioni privilegiate della vita, perché comunicano i sentimenti più profondi e le risonanze interiori di avvenimenti importanti dell’esperienza umana.
Il canto e la musica sono particolarmente adatti ad esprimere il lato ‘spirituale’ della persona, la parte più interiore e profonda di noi.
La musica è una specie di linguaggio dell’anima (e non è un caso che la parola musica e la parola mistero abbiano la stessa radice mu, che dà origine all’antico verbo myo, che significa ‘chiudere la bocca’, per indicare tutto ciò che non può essere detto a parole e necessita di altri linguaggi, come i gesti o i suoni simbolici.
Questo spiega perché ogni volta che l’uomo, di tutti i tempi e di tutte le culture, ha cercato di raccontare, ricordare o celebrare qualcosa di importante della sua vita, non si è accontentato della semplice parola, ma ha sentito il bisogno di un linguaggio più forte, capace di esprimere l’indicibile.
E spesso ha utilizzato il canto. In particolare, l’esperienza del rapporto con la divinità è stata vissuta costantemente con l’ausilio del linguaggio cantato. Tutti i riti religiosi, di qualsiasi religione, prevedono la presenza del canto.
Eccoci dunque ad un primo punto fermo: il canto liturgico va considerato prima di tutto come un modo di esprimersi e di esprimere contenuti umani e spirituali che il semplice linguaggio verbale non riesce a esprimere. Anche nella liturgia il canto è stato assunto proprio in quanto fenomeno umano, prima che fenomeno musicale.
A questo possiamo aggiungere che l’essere umano è fatto non solo per pensare e parlare, ma anche per cantare. Basta osservare la nostra conformazione fisica e psichica. Il nostro corpo è predisposto per la parola e per il canto. Il corpo è in qualche modo anche uno strumento musicale, che produce il canto.
Alcuni dei suoi organi servono anche per cantare. L’addome, i polmoni, le corde vocali, la bocca e i muscoli facciali non servono solo per respirare e parlare. Sono fatti anche per cantare.
Il professore francese Alfred Tomatis, otorinolaringoiatra e chirurgo, che ha dedicato la sua vita alle ricerche sull’ascolto, il linguaggio e la comunicazione, scrive:
Le corde di un violino, di un violoncello o anche di un piano sono soltanto mezzi per trasmettere le vibrazioni, ma non lo strumento in quanto tale. Nel canto lo strumento è il corpo, e le corde vocali costituiscono gli elementi che lo mettono in risonanza.
Qualcosa di simile, con intenti più spirituali, viene detto molti secoli prima, addirittura all’interno di un’omelia, da san Giovanni Crisostomo:
«Canterò con lo spirito, canterò con l’intelligenza (cf 1 Cor 14, 15).
L’anima è un ottimo musicista, un artista: il corpo, invece, è lo strumento, che prende il posto della cetra, del flauto e della lira…
Dio ti vuole qui insegnare che tu lo devi sempre lodare e benedire, perché egli ha curato che lo strumento fosse sempre congiunto con l’artefice.
Gli altri cultori di musica ora usano uno strumento ora non l’usano. La loro vita non è un canto continuo e, quindi, non usano sempre gli strumenti necessari per il canto.
Il Signore, volendo insegnarti che tu devi sempre lodare e benedire, ha fatto sì che lo strumento per cantare le sue lodi (il tuo corpo) sia sempre unito a te. Che devi sempre pregarlo, te lo dice con l’Apostolo: pregate senza interruzione. Rendete grazie in ogni cosa (1 Ts 5, 17-18)».
(GIOV. CRISOSTOMO, In Ps 145, 3, PG 55, 522).
Così arriviamo ad una conclusione importante: cantare non è solo un gesto culturale, non è un linguaggio per esperti (lo diventa ad un certo livello). Cantare è prima di tutto un gesto ‘naturale’. La ragione fondamentale per cui cantiamo è che il corpo umano è predisposto anche per cantare.
La particolarità dell’espressione canora
«Ad un famoso pittore russo fu chiesto un giorno perché non si fosse mai cimentato nell’arte del dipingere un’icona. Egli rispose, sicuro e sereno: “perché non sono un santo!”».
Pensiamo all’iter che precede ed accompagna l’atto di dipingere una icona. Un’icona non è un semplice dipinto a soggetto religioso, né un sacro dipinto, ma è parte integrante della liturgia ortodossa. L’insieme delle icone che formano l’iconostasi, che separa fedeli e presbiterio con i ministri del rito, rappresenta la mediazione visiva dell’invisibile ed indescrivibile mistero che si perpetua sull’altare. (…) Chi è chiamato a dipingere una icona, vive davvero una dimensione ‘santa’. L’icona nasce da un profondo itinerario spirituale, il quale le garantisce di essere ‘liturgica’.
Un analogo percorso potrebbe essere fatto con il canto. Se ci chiediamo dove sta la differenza tra il parlare e il cantare, la risposta più significativa a livello psicosomatico, è che quest’ultima azione coinvolge una persona molto più della semplice parola. La cosa è evidente. Per cantare ci vuole più abbondanza di respiro, più ricchezza di espressione, più attenzione, più coordinamento dei muscoli facciali e addominali, una particolare impostazione della bocca e del corpo, uno specifico trattamento delle corde vocali ecc.
Del resto proprio per questo produce in chi ascolta un effetto maggiore, riesce a stabilisce un di più di relazione e di comunicazione. È una conseguenza logica. Dove c’è più coinvolgimento psicosomatico, c’è anche più comunicazione.
La differenza tra parlare e cantare sta proprio in questo di più di presenza di sè, di coinvolgimento interiore e di espressività.
Per cui nel canto c’è più dono di sé. Si dona qualcosa di più di se stessi che non nel parlare. E donando di più si riesce quasi sempre a stabilire anche un di più di relazione e di comunicazione.
“Chi canta bene prega due volte», dice un antico adagio. Solitamente lo si usa per dire che il canto vale di più davanti a Dio o che Dio lo ascolta più volentieri.
Penso invece voglia dire soprattutto che chi canta ci mette molto di più, più corporeità e più energie, più coinvolgimento della persona e più dono di sé. Per cui cantando si ottiene un effetto doppio:
– quello di sintonizzarsi sul modo di essere di Dio, perché Dio è dono,
– e quello di sentirsi più prossimi agli altri, perché quando si dona, ci si avvicina l’uno all’altro, si eliminano in qualche modo le distanze, si crea prossimità.
E allora si capisce perché il Concilio ha affermato che il canto non è solamente un elemento estetico nella liturgia; esso è un linguaggio privilegiato per la preghiera del cristiano (di ogni cristiano!). Si canta perché, se l’eucaristia è esperienza di comunione, il canto è il linguaggio più forte che ci permette di fare comunione.
E’ possibile fare un curioso accostamento. Partiamo dalla definizione della musica (in genere) da un punto di vista fisico-acustico: la musica è un insieme di vibrazioni, di corpi che risuonano (corde, aria). La musica è fatta di
“realtà corporee che entrano in risonanza per una misteriosa consonanza in cui elementi diversi, insieme, partecipano della stessa vibrazione”.
La musica nasce dalla risonanza di queste onde, di queste vibrazioni.
Riprendendo questa immagine, il canto liturgico appare come il momento più alto in cui l’uomo, con tutto, viene toccato fisicamente, spiritualmente, psichicamente da Dio e, risuonando interiormente, entra in vibrazione con Lui.
Perché, dunque, si canta in liturgia?
Si canta perché è necessario cantare. (motivo rituale)
– Necessario perché ci sono riti e gesti che esprimono meglio e più compiutamente il loro significato se sono accompagnati dal canto (ovviamente se è un canto adatto);
– In secondo luogo perché ci sono alcuni riti e gesti che sono canti. hanno senso più pieno se cantati, comunque, utilizzando il linguaggio musicale (Gloria…Santo, Alleluia…, Mistero della fede… Per Cristo, con Cristo…Tuo è il Regno …Agnello di Dio).
Ma c’è anche (oltre a quello rituale) un motivo antropologico:
– Proprio perché il canto è un’espressione forte dell’essere umano il cristiano deve cantare: la gioia che deriva dalla fede nel Cristo risorto è la prima ragione del cantare del cristiano.
– E poi la liturgia è ‘culmine e fonte della vita cristiana’, è cioè l’esperienza più alta della vita della Chiesa; per questo c’è bisogno del linguaggio migliore, più ricco…
Il canto di chi?
“Liturgia” significa “azione di popolo”. Cioè è degna di essere chiamata come liturgica un’azione che ‘coinvolge’, vede tutti, in un modo o nell’altro, protagonisti.
Scopo di questa ‘azione di popolo’ è di entrare in collegamento con Dio. E’ incontro con Dio insieme.
Uno potrebbe dire: perché c’è bisogno di farlo insieme? non posso arrangiarmi da solo per entrare in comunione con Dio?
E’ stato Gesù a volerci insieme: infatti Gesù non si è presentato come l’alpinista solitario che compie da solo la sua scalata; Gesù si è presentato come la vite di cui noi siamo i tralci, come la Pietra angolare del Tempio nuovo di cui noi siamo le pietre vive, come la guida del gregge di cui noi siamo le pecore.
Gesù si è presentato come colui che mette insieme, che raduna tutti. Questa preoccupazione di Gesù è diventata la preoccupazione e la missione della chiesa: riunire tutti gli uomini.
Ed ecco anche perché il Concilio Vaticano II° ha dato priorità assoluta al valore dell’assemblea. L’assemblea è la fotografia della Chiesa.
E questo è il motivo per cui il grande sforzo da fare è quello di ricreare assemblee che cantano. Ci viene chiesto di fare ogni sforzo possibile per far crescere il canto dell’assemblea, o se volete, perché le nostre assemblee imparino a celebrare cantando, che non significa tanto riempire di canti una celebrazione, ma vivere l’esperienza celebrativa con il linguaggio del canto.
Perché se la liturgia è esperienza di comunione con Dio e tra di noi, noi non possediamo un linguaggio di comunione più forte di quello del canto. Basta pensare a quello che succede quando cantiamo insieme: rinunciamo al proprio tono di voce e al proprio ritmo per unirci in un unico tono e un unico ritmo. Quindi stesse parole, pronunciate rigorosamente nello stesso tempo grazie alla precisione del ritmo, e cantate esattamente alla stessa altezza grazie alla nostra scala musicale fissa: l’unisono è il segno più evidente della unanimità dei cuori che si esprimono. Come dire, se vogliamo esprimere l’unanimità non c’è niente di meglio di un canto all’unisono. Vedete quindi che il canto ha un significato e un contenuto al di là e prima ancora di quali parole noi cantiamo. Il valore sta nel fatto stesso di cantare.
IL CANTO ALL’UNISONO COME SIMBOLO DI UNITÀ
Questo tipo di considerazione, di solito spaventa le corali, che si sentono impoverite, non potendo esprimere con tranquillità le loro capacità vocali nella polifonia. in realtà non è così. Se l’unisono evidenzia l’unità dei credenti, c’è comunque spazio anche per la plurivocalità.
Anche il cantare a più voci è un simbolo.
Ci sono momenti, come quando si canta un corale, in cui le voci pronunciano il testo nello stesso tempo. Esse traducono, in questo stile, l’unità del coro attraverso la diversità delle voci. La natura ci ha creati diversi, donne e uomini, voci acute e voci gravi. La bellezza raggiunta dall’assemblaggio di queste voci diverse diventa simbolo dell’armonia di una umanità nella quale ciascuno è riconosciuto e apprezzato per il suo carattere proprio.
Quando la corale esegue un’ opera polifonica nel senso classico del termine, cioè quando le voci entrano le une dopo le altre, si rispondono e si stimolano in questo dialogo incessante, la musica simbolizza, oltre alla diversità delle vocazioni e dei temperamenti, anche la differenza dei nostri ritmi di cammino e dei nostri impegni, le nostre lentezze e i nostri slanci, i nostri momenti di entusiasmo e di rilassamento.
Più che il semplice valore decorativo che le si domanda abitualmente e che talvolta le si rimprovera, la polifonia mi sembra abbia il suo posto in liturgia per questa immagine sonora simbolica che è in grado di portare alla celebrazione.
Quando un canto svolge una funzione liturgica?
Per rispondere a questo interrogativo ci viene in aiuto un passo della Bibbia, straordinario, dove il suono e il canto sono descritti come capaci di provocare, quasi chiamare la venuta, l’incontro con Dio.
Siamo nel secondo libro delle Cronache: la costruzione del tempio (siamo al tempo del Re Salomone) è ultimata; il sacro edificio risplende in tutto il suo fulgore e trionfo di arte. Per il Signore è stato fatto e speso il massimo. L’arca è introdotta nel cuore del tempio, ma
«avvenne che, usciti i sacerdoti dal Santo (…) mentre tutti i leviti cantori (…) vestiti di bisso, con cembali, arpe e cetre, stavano in piedi a oriente dell’altare e mentre presso di loro centoventi sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all’unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore (…) allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore» (2 Cr 5,11-13).
La presenza del Signore non è un evento casuale, magico: solo quando si leva potente la voce dei cantori e il suono degli strumenti il tempio si riempie della sua gloria. Qui il suono e il canto diventano liturgia.
Un canto è liturgico se e quando concorre a realizzare il senso e la finalità dell’azione liturgica. E la finalità della liturgia non è di realizzare belle cerimonie, ma di permettere, oggi, l’incontro tra Dio e il suo popolo.
Cosa significa, poi, per il canto liturgico, il fatto che ogni liturgia è rivolta al Padre, per Cristo, nello Spirito?
Il Padre del nostro Signore Gesù Cristo è il destinatario di tutta la liturgia cristiana; è colui al quale ci si rivolge, come singoli e come assemblea. Egli è il grande assente, avvertito presente nella fede; egli è il primo e il grande ascoltatore della liturgia cristiana. E’ in vista di lui che il rito esiste. Il primo senso di ogni rito è la glorificazione del Padre, la santificazione del suo nome.
Si canta “per la gloria di Dio”
La fondamentale dimensione della liturgia è quella eucaristica nel senso letterale, come rendimento di grazie, azione di grazie.
La prima nota di una spiritualità del canto liturgico non può non essere questa dimensione eucaristica del proprio essere: essere-per-l’altro, per il Totalmente Altro, per Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il canto partecipa di questo orientamento globale della liturgia.
Il Padre è colui al quale va realmente indirizzato, dedicato il canto. Non l’assemblea, ma lui è il primo ascoltatore: si canta a Dio, per lui, per la gloria del suo nome.
E’ un grande tradimento quando il canto è sentito nella liturgia come spettacolo umano, come esibizione alla platea (sia pure il papa o il vescovo), quando è dedicato all’altro e non all’Altro, quando, invece di dare gloria al Padre, vorrebbe attirare un po’ di gloria e di plauso su di sé.
Una spiritualità del canto liturgico esige questa purezza originale di intenzione, di destinatario.
Si canta, dunque, per la gloria di Dio. Non soltanto perché si canta e si suona gratis. Non soltanto perché non si mette al primo posto il fare bella figura.
Cantare per la gloria di Dio significa cantare perché la sua gloria si manifesti; perché Dio scenda in mezzo al suo popolo, appaia agli occhi della fede oltre la soglia delle cose che si vedono, oltre la soglia delle persone che cantano, e faccia succedere quello che Egli vuole far succedere “per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa”.
Cantare per la gloria di Dio significa offrire il proprio canto affinché l’opera di salvezza che Dio compie attraverso l’azione liturgica possa avere successo. In altre parole, significa cantare non perché Dio resti in alto, lontano, seduto sul suo trono ad ascoltare e ad approvare, ma perché “scenda” e rinnovi il mistero della incarnazione nel cuore dell’assemblea e di ogni credente.
Il canto è liturgico se e quando contribuisce a portare Dio su questa terra, affinché la presenza di Dio prenda forma, continui ad avere forma umana come in Gesù di Nazaret, prenda la forma dell’assemblea radunata e attraverso di essa si proponga di nuovo come “la luce che salva” al popolo che ancora cammina nelle tenebre.
Questo è lo scopo della Liturgia. Questo è lo scopo cui devono servire i nostri riti e i nostri interventi, canto compreso, perché si possa dire che sono liturgici.
CONCLUSIONE
Perché l’assemblea arrivi a celebrare cantando, deve essere educata al canto. Dobbiamo far capire loro che sono convocati anche per cantare e per cantare insieme: cantare la propria fede nel Cristo risorto, cantare la speranza che portano nel cuore, cantare la gioia di sentirsi amati da Dio…
Mons. Adriano Caprioli, vescovo emerito di Reggio Emilia, qualche anno fa, introducendo i lavori di un Convegno dei responsabili diocesani per la musica, tenutosi a Palermo, ha lanciato proprio questa provocazione: l’impegno di iniziare i battezzati alla fede comporta anche l’impegno di educarli a pregare e a cantare in chiesa, man mano che crescono.
Un’assemblea che non canta – nel senso pieno della parola – non è un’assemblea liturgica. Se non canta, non è (o, almeno non è sempre) perché non conosce il canto proposto; è perché non ha il canto nel cuore. E se non ha il canto nel cuore, come può fare l’Eucaristia? Affidare il canto a un gruppo di ragazzi o di professionisti o di dilettanti non risolve il problema. E più facile certo; ma è la tecnica del rattoppo, tanto deprecata da Gesù: “Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore” (Mc 2,21).
don Pierangelo Ruaro, direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di Vicenza