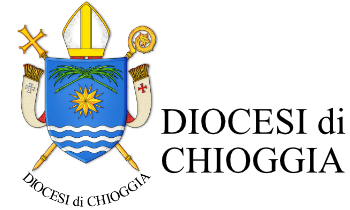OTTOBRE MISSIONARIO. Seconda settimana
Non una mano tesa, ma due braccia aperte
In questa seconda settimana, dedicata al tema della vocazione, proponiamo come riflessione l’intervista fatta a don Gianni Cesena, direttore di Missio (organismo pastorale della CEI), che spiega cosa rappresenta l’ottobre missionario per la chiesa e gli sviluppi dell’Ad Gentes.
La missione è un “termometro” della fede? Si può dire di sì quando la spinta all’annuncio nasce da una scelta spirituale profonda e matura. Un segno di vitalità e speranza nel difficile momento storico che stiamo attraversando, segnato da molte crisi: da quella dei mercati a quella delle tradizionali agenzie educative, come la famiglia, la scuola, ma anche le stesse comunità cristiane. Su tutto pesa un deficit di fede che si esprime nel calo delle vocazioni religiose, in una diminuita disponibilità alla solidarietà. Ne parliamo con don Gianni Cesena, direttore di Missio, che spiega: «Quando si fanno delle
analisi, indicando i molti elementi di crisi, che peraltro sono sotto gli occhi di tutti, non ci si dovrebbe dimenticare di guardare l’altra faccia della medaglia. È vero che c’è un calo di vocazioni religiose, ma contemporaneamente nel campo missionario si registra un allargamento alle vocazioni laicali. È vero che c’è una diminuita disponibilità alla solidarietà, soprattutto alla solidarietà del “breve rapporto”, però permane sempre un’attenzione all’approccio culturale e sociale. C’è una solidarietà al di fuori dei confini della Chiesa che qualche volta, come comunità cristiana, non sappiamo valutare».
Quali sono oggi le nuove frontiere pastorali della missione? «Apparentemente la missione sembrerebbe essere piuttosto una perdita d’identità perché significa dire il Vangelo di sempre con linguaggi di altre culture, di altri popoli. Ma è proprio nel confronto con queste tradizioni quotidiane degli altri popoli che si misura la fede, poiché trascende le culture, anche la nostra cultura che pure ne è impregnata. È quando si comunica, che si può misurare la temperatura della nostra fede e vedere se è accettabile oppure se è fredda e incapace di comunicare calore agli altri». Lo slogan della Giornata missionaria mondiale di quest’anno “Ho creduto perciò ho parlato” è un richiamo ad una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle comunità cristiane? «Credo che, prima di parlare di responsabilità, occorra chiedere alle comunità cristiane di esistere come tali. La coincidenza di due importanti eventi ecclesiali, come l’Anno della Fede e il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, sembra pensata soprattutto per ricordare che le comunità cristiane sono tali per entrambi i termini dell’espressione. Quindi che abbiano fede e che siano comunità eloquenti, in grado di essere autentici luoghi di irradiazione del Vangelo».
Una fede fredda, vecchia non è in grado di esprimere una forza missionaria autentica…
«Senza dubbio. Credo che nel nostro Occidente molte persone, dentro e fuori le nostre comunità, non siano prive di fede ma è un sentimento così condizionato dagli aspetti quotidiani del vivere che non ci si pone più il problema della propria autenticità e dell’apertura verso l’altro. L’Anno della Fede ci richiama non solo ai contenuti ma ad una fede professata e celebrata, che si mostra nella società lasciandosi interpellare dalle altre culture».
Cosa ci si aspetta dal Sinodo?
«La preparazione del Sinodo ci ha presentato due aspetti importanti: il primo è il recupero del Concilio Vaticano II, non solo dei suoi testi, ma anche del suo approccio al mondo. È il segno di una Chiesa che non sta davanti “al” mondo, ma che vuole condividere il cammino “del” mondo. Una Chiesa che vuole immergere i piedi nella polvere delle strade, perché così ha fatto Gesù nel mistero della sua incarnazione. Una Chiesa che sta su una cattedra o, peggio, su un seggio di tribunale, non serve a se stessa, non serve al mondo. Credo anche che ci si aspetti dal Sinodo una nuova inculturazione della fede per il mondo occidentale. La cultura occidentale ha assunto tutti i valori cristiani, estrapolandoli talvolta dal riferimento esplicito a Gesù: il risultato è che questi valori in parte rimangono autentici, in parte impazziscono producendo nuove ideologie o “pensiero debole”».
Nell’ecclesiologia cattolica la missione è anche cooperazione tra Nord e Sud, tra le giovani Chiese e quelle di antica tradizione. Siamo pronti?
«Potremmo anche non essere pronti. Ma oggi siamo di fronte al fenomeno migratorio che non solo ci porta persone delle altre Chiese (del Sud del mondo) ma anche fedeli protestanti, ortodossi e di altre religioni. Questo ci interpella: il metodo missionario è quello di annunciare il Vangelo là dove non è stato pronunciato o di condividerlo là dove sembra ci siano fratture e divisioni superiori alle ragioni di unità. L’Instrumentum Laboris del Sinodo cita la convinzione di Giovanni XXIII che “ciò che ci unisce è più di ciò che ci divide”».
È ora che le Chiese di antica tradizione abbandonino lo stile paternalistico che spesso è stato usato nei confronti delle giovani Chiese?
«Se parlo con i missionari o leggo le riviste specializzate, trovo che questo approccio paternalistico non è più tanto presente. Purtroppo lo è nella maniera comune di intendere la missione, anche da parte di tanti piccoli e grandi organismi che cercano di fare quello che possono, ispirati dal loro senso di solidarietà. Per abbandonare questo approccio occorre guardare all’altro così com’è. Vedere davanti a noi non una mano tesa ma due braccia aperte. Perché attraverso l’abbraccio possa avvenire lo scambio. Dobbiamo imparare dai giovani che ovunque sanno mescolarsi in mezzo alle novità senza fermarsi di fronte alle diversità e sanno intrecciare relazioni nuove: essi sono un mondo culturale intrigante per noi che dobbiamo imparare da loro la semplicità».
da NUOVA SCINTILLA 37 del 7 ottobre 2012